|
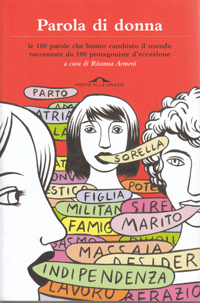 Nel nuovo libro di Ritanna Armeni troverete cento donne
Nel nuovo libro di Ritanna Armeni troverete cento donne
e cento parole. O meglio cento parole spiegate e raccontate
da altrettante giornaliste, scrittrici, filosofe, registe, sociologhe,
storiche, sindacaliste e politiche il loro intento è provare
il cambiamento provocato attraverso la testimonianza
delle parole. Per gentile concessione dell’autrice
e della casa editrice, riportiamo parte dell’introduzione
e tre delle cento parole che compongono
il libro ‘Parola di donna’ (Ponte alle Grazie)
In questi anni, vecchi termini hanno indicato cose e fatti diversi dal passato, la stessa parola si è trasformata assumendo significati differenti, rovesciando quelli vecchi e illustrando nuovi pensieri, nuove convinzioni.
Pochi se ne sono accorti. Molti hanno preferito ignorare quanto il senso e il significato delle parole non sia più quello di una volta. E di conseguenza non interrogarsi e non arrivare a una conclusione probabilmente temuta dai più. Il significato di molte parole è mutato perché sono cambiate le donne e con loro il mondo e gli strumenti coi quali lo si descrive.
Naturalmente le parole che testimoniano questa trasformazione sono molte, ben più delle cento illustrate in queste pagine.
Abbiamo fatto una scelta collettiva e individuale seguendo le inclinazioni di ognuna, ma anche gli studi, le competenze, gli interessi. Nessuna pretesa di completezza e di oggettività. E neanche di omogeneità di stile e di linguaggio. Attraverso il racconto di una parola si può trovare piuttosto la consegna di un vissuto e di una storia che sono intessuti di emozioni e pensieri, di sentimenti e di studi, di presa di coscienza e di intenzione di comunicare.
Troverete le parole del femminismo. Quelle che la rivoluzione degli anni ‘70 ha messo al centro del pensiero e del discorso di tante donne italiane: autocoscienza, personale, piccolo gruppo, autodeterminazione. E ancora: liberazione, differenza, relazione, emancipazione, parità. Parole sorpassate in un mondo che spesso guarda con ironia a ciò che racconta l’inizio della rivoluzione più lunga e radicale degli ultimi cento anni? Forse.
Ma quando si possono dire superate e sorpassate alcune parole? Certo oggi non fanno parte, come nel passato, della vita e del discorso comune delle giovani donne. Ma hanno davvero perso di significato, esaurito la loro spinta propulsiva oppure, anche se non pronunciate con la frequenza di un tempo, anche se oramai facenti parte della storia più che del presente, influenzano i comportamenti, la storia di oggi? [...]
Il cambiamento ha attraversato la quotidianità e il privato, ma lo ha superato. Oggi parlare di diritti, di potere, di politica, di destra e di sinistra, di lavoro obbliga a un confronto con quello che le donne hanno prodotto nella lingua e quindi nella cultura e nella realtà. Il loro pensiero ha cambiato molti mondi e modelli maschili. In alcuni casi ha provocato una rivoluzione culturale e distrutto assiomi che parevano storicamente consolidati. […]
Ci sono parole difficili ed eterne che sembrano appartenere a un universo concettuale asessuato e universale che coinvolgono e si rivolgono all’umanità tutta. Parole come desiderio, sentimento, amore, morte, tempo, solidarietà, eguaglianza, speranza, erotismo, scienza, religione hanno attraversato la storia del mondo, e continueranno ad attraversarla. Ma non si era fatto abbastanza caso al fatto che non sono state pronunciate nello stesso modo degli uomini dalle donne. Queste ultime lo hanno fatto in modo sicuramente più sommesso, meno riconosciuto.
E dando loro un significato che è rimasto ai margini della storia. È stato sicuramente più flebile nella storia del mondo la parola del desiderio femminile. E persino la morte, che ci riguarda tutti, si è piegata a un dominio culturale maschile. Per non dire della religione e della scienza, dei sentimenti.
Oggi scopriamo che le donne possono spiegare di nuovo e in modo differente quasi tutte quelle parole. Che si sono riappropriate e hanno dato un senso nuovo a quelle da cui erano state estromesse. Che le hanno attraversate e inventate di nuovo, distruggendo quelle che parevano categorie eterne, invariabili, a sesso unico. […]
La voce delle donne che spesso si ascolta come un mormorio indistinto, magari come canto fatato e affascinante, si fa parola distinta e chiara che vuole spiegare il mondo. E proprio per questo non è parola omogenea. Non usa gli stessi strumenti, ma quelli che possiede più fortemente e intimamente. Le scrittrici non possono raccontare il mondo come le sociologhe, le storiche non spiegano come le giornaliste. Ciascuna ha una sua cifra personale e distinta, anch’essa segnale di un cambiamento.
Non sono uguali l’una all’altra e non lo sono neppure nel modo di esprimere il cambiamento. La distinzione e la differenza anche nel racconto di una parola sono il segno di una ricchezza che loro hanno imparato a valutare e a raccogliere. […]
Sono ancora colpita dalle risposte alla mia richiesta. Disponibilità, curiosità, interesse ed entusiasmo per il progetto. Collaborazione, fiducia e, ancora, un vivo senso di militanza. Mi sono chiesta se cento uomini avrebbero avuto la stessa reazione. E naturalmente mi sono data una risposta.
Dall’introduzione del libro
di Ritanna Armeni
___________________
Destra - Flavia Perina
«Le mie nonne italiane, due donne senza alcuna educazione, avevano più potere delle femministe di oggi, avevano più maestà e controllavano tre generazioni, grazie solo al rispetto che avevano per essere madri». La citazione è di Camille Paglia, all’inizio degli anni ’90, ma rappresenta bene il punto di vista da cui partì la storia del «femminismo di destra», cioè l’analisi del ruolo della donna nelle società tradizionali in contrapposizione con il modello remissivo e subordinato proposto dalla cultura borghese e del mito dell’emancipazione che la sinistra aveva mutuato dal femminismo americano. Anagraficamente, la vicenda dei movimenti femminili di destra è piuttosto breve, germoglia all’inizio degli anni ’70 e si conclude nei ’90. Prima, come ha osservato la mia amica Annalisa Terranova nel suo Camicette nere, l’identità femminile a destra era assente o quasi invisibile salvo rare eccezioni come Cristina Campo, raffinata e dimenticata scrittrice, o Carla De Paoli, animatrice di una rivista molto importante per quel mondo, L’Italiano di Adriano Romualdi.
Il ventennio della «rivoluzione rosa» nasce senza dubbio dalla nuova soggettività giovanile emersa nel Sessantotto, che riempie (anche) le sedi missine, fino ad allora piuttosto polverose, di una moltitudine di ragazzi e ragazze. E siccome tutto è politica, e siccome c’è l’ambizione di una weltanschauung che declini ciò che è «nostro» fino ai dettagli, le ragazze cercano le coordinate di una visione della donna alternativa, una terza via tra il modello Gigliola Cinquetti e il pugno chiuso di Angela Davis. Bocciano istintivamente la guerra tra i sessi, l’idea della rivoluzione come riappropriazione del corpo (di corpo, a destra, non è mai venuto in mente a nessuno di parlare), ma anche lo stereotipo dell’angelo del focolare, il familismo, l’idea gerarchica del patriarcato. Trovano la soluzione nel simbolo tradizionale dello yin e yang e nel concetto di complementarietà tra uomo e donna. Il gruppo di Eowyn, nato tra il 1979 e il 1980 e consolidato intorno alla rivista che porta il nome dell’eroina di Tolkien, è uno dei motori del «gramscismo di destra» dell’epoca insieme agli ecologisti dei Gre, Gruppi di ricerca ecologica, ai centri librari, ai gruppi rock, all’underground della Voce della Fogna. Per spiegare il mood di quelle ragazze il modo più sintetico è raccontare cosa fanno oggi: Stefania Paternò, padovana e leader del gruppo, è mediatrice culturale per la Regione Veneto, si occupa di immigrate e diritti; sua sorella Cristiana fa la ginecologa di base; Monica Centanni è grecista e insegna all’università di Venezia, promotrice del Manifesto d’ottobre degli intellettuali per una nuova politica; Marilena Novelli è dirigente scolastico del Lazio; Annalisa Terranova è giornalista al Secolo e scrittrice; Isabella Rauti è stata a lungo dirigente del Dipartimento per le Pari opportunità del ministero e oggi è consigliere regionale del Pdl nel Lazio. La sottoscritta è parlamentare di Fli e direttore del Secolo d’Italia.
Tutte hanno riabilitato in qualche modo il femminismo e l’idea che i diritti della donna debbano essere oggetto di una costante difesa e «manutenzione» dopo aver verificato che la complementarietà poteva forse funzionare in una società ideale, alla corte di re Artù o nella tolkeniana Terra di Mezzo, ma non certo nelle turbolenze della post modernità. Ma nella loro/nostra visione restano alcune distanze incolmabili rispetto all’esperienza femminista, a cominciare dall’analisi della cosiddetta «società sessista» con l’implicita attribuzione alla donna del ruolo di soggetto debole che deve emanciparsi, liberarsi, ribellarsi al «maschio padrone». Anche qui, le biografie spiegano assai più dei riferimenti ideologici. La nostra rivoluzione antiborghese, il nostro rifiuto – per dirla con Simone De Beauvoir – di essere «l’altro», il «secondo sesso», la «seconda scelta», l’avevamo già fatta, e assai radicalmente, uscendo fuori dal perimetro del politicamente corretto dell’epoca. Non aveva a che vedere con il nostro essere donne, ma con l’aver scelto una parte politica bandita e nel pretendere comunque di avere voce e ruolo nella società. Nel piccolo del nostro mondo eravamo molto rispettate, e sempre trattate alla pari, anche perché la promozione della donna era uno dei topic più citati nei convegni sull’eredità degli anni ’30 cui il neofascismo del dopoguerra faceva riferimento. Le Giovani Italiane, l’Opera maternità e infanzia, lo sport aperto alle ragazze in scandalosi calzoncini corti, le prime donne in divisa e nei ranghi dell’esercito: questo era il retaggio di riferimento, raccontato come una rupture rivoluzionaria col modello del moralismo ipocrita dell’Italietta sabauda. Di nostro, in questo rapporto paritario col «maschio», ci avevamo messo un notevole livello di autocontrollo personale, fondato sul rifiuto di ogni vantaggio della seduttività. Si doveva leggere, studiare, impegnarsi, non per «essere alla pari» o tantomeno uguali, ma perché la politica era questo: conoscenza, idee, costruzione. Il corpo, la sessualità, d’altronde, a destra non sono mai entrati nel dibattito femminile.
Erano un dato di fatto ineludibile ma privato. Uno dei punti caldi della polemica col femminismo era il rifiuto dello stereotipo «il personale è politico», lo slogan mutuato dal movimento femminista americano che indicava nelle relazioni uomo-donna e soprattutto nella famiglia il nocciolo duro dell’oppressione che determina l’inferiorità sociale della donna. È da quel rifiuto che arriva dritto il nostro disagio di oggi davanti alle commistioni tra politica e gossip: il personale, per noi, è stata sempre una dimensione di cui avere pudore, la terra delle contraddizioni, dei sentimenti controversi e al limite delle stupidaggini, non un paradigma politico da rettificare per costruire un mondo migliore. E l’eros lo abbiamo sempre visto come la frontiera dove «le buone intenzioni cedono a pulsioni primitive», per citare ancora Paglia, il misterioso crocicchio di Ecate «dove tutte le cose tornano nella notte», il luogo «dell’illecito, della dannazione e dell’incanto».
Comunque, l’interscambio fra destra e sinistra, persino nella stagione degli opposti estremisti, è più denso di quello che normalmente si immagina. Ci sono dati pre-politici, esistenziali, che accomunano le esperienze anche dove l’ideologia le divide con il coltello. Lo spirito antiborghese è uno di questi, e negli anni della contestazione cuce insieme icone di destra come Evita Perón e di sinistra come la Jane Fonda dei tempi d’oro.
La coppia immaginaria più «giusta» della mia giovinezza, non a caso, era costituita dal «fascista» Corto Maltese e dall’emancipata Valentina di Crepax. Lui avventuriero oltre ogni moralismo, lei «bella e possibile come tutte vorremmo essere» (lo ha detto Maria Laura Rodotà e condivido). Compagni o camerati che fossimo, ci innamorammo di loro su Linus, senza eccezioni: tutte avremmo voluto essere Valentina e avere un fidanzato come Corto, e viceversa.
Per tornare alla politica, la breve stagione del femminismo di destra è fondata innanzitutto sulla rivendicazione di diritti sociali e individuali – maternità consapevole, lavoro, sostegno sociale, pari retribuzioni – che prendano atto della specificità femminile e le offrano pubblica tutela. Dopo un quindicennio di effervescenza si inabissa nel 1990 con l’affermarsi dell’era delle pari opportunità e la sua pretesa di imporre una cultura di definitiva ricomposizione delle diversità (nobile e irrealizzabile utopia). Nuota sott’acqua per un decennio, mentre l’era delle pari opportunità si trasforma in stagione della lagna. Comincia a riemergere dopo il 2000 con la questione delle quote rosa e con l’affermarsi del modello femminile berlusconiano che eclissa decisamente ogni precedente esperienza. Non è difficile capire perché il nostro mondo si trovi a disagio davanti alle modalità di intervento politico di una Santanché o di una Brambilla, che tuttavia suscitano più contrappunto ironico che indignazione.
Niente di nuovo sotto il sole per chi da bambino ha letto Dumas, anche se le Milady di una volta avevano probabilmente più classe e non strillavano in tv. Sullo sfondo, la convinzione che è urgente rilanciare – e stavolta oltre le categorie ideologiche – un qualcosa che «riabiliti» l’immagine femminile restituendole orgoglio e spessore, ricostruendo a destra icone più degne delle ‘Letterine’ o delle ‘Gheddafine’ che hanno monopolizzato l’immaginario dell’ultimo quindicennio.
Flavia Perina, politica e giornalista,
ex direttore del Secolo d’Italia
________________________
Lavoro - Susanna Camusso
Nell’immaginario collettivo e comune il lavoro è quello retribuito, in cui c’è uno scambio tra attività svolta, professionalità utilizzata e salario. È questo il lavoro che appare sulla scena pubblica, quello classificabile, che si esamina e si studia. Ed è quello le cui modalità di svolgimento sono incardinate sul modello maschile.
Questo modello non vede, non pensa e non ritiene (a volte esclude) che la relazione, la cura, gli affetti, la genitorialità, l’accudimento, l’assistenza, la gestione del tempo, siano anch’esse forme di lavoro, anche se non retribuito, non visibile e, pertanto, semplicemente ignorato. La donna, le donne, non svolgono un solo lavoro, ma due: quello retribuito e quello gratuito e invisibile. Questa duplicità e questa molteplicità sono connaturate alla loro vita.
È dall’antichità che le donne lavorano. Il mestiere più antico del mondo si potrebbe dire, smentendo luoghi comuni, è rappresentato da quello delle donne nei campi.
Il punto è che questo lavoro non è mai stato riconosciuto e non lo è neppure oggi. Eppure non è difficile. Basterebbe provare a fare e a far fare, a tutti, un esercizio molto semplice. Si dovrebbe provare a immaginare la nostra società e la vita di ognuno, tutti i giorni e in ogni luogo, priva del lavoro delle donne. Emergerebbero con chiarezza la multiformità e la molteplicità delle loro attività.
Quella molteplicità di attività pubbliche private, retribuite e gratuite che ha fatto coniare la definizione appropriata di «acrobate del tempo». Oggi non esiste un’analisi del lavoro dal punto di vista di genere. Esso viene descritto e valutato su due piattaforme parallele diverse: quella delle donne che rimane interna al loro vissuto e quella usata dalla politica e dall’economia, che gode del crisma della scientificità, e contribuisce ad alimentare l’immaginario comune e il pregiudizio.
E, infatti, quando le donne sono entrate nel mercato del lavoro in modo visibile e consistente, il loro apporto è stato considerato integrativo e aggiuntivo all’economia della famiglia. Un apporto non strettamente necessario, dal momento che altro era il loro ruolo. Rimane solida, in questa visione, il pensiero che vede nella famiglia e nella casa il «luogo delle donne».
Con questa idea che il lavoro delle donne sia aggiuntivo e integrativo dell’economia familiare si negano alla radice gli aspetti identitari, sociali, di affermazione di sé, di equa distribuzione che sono interni allo stesso concetto di lavoro. Si negano, peraltro, anche le grandi lotte operaie e contadine che nel passato le stesse donne hanno fatto per affermare – in quel grande movimento che oggi possiamo leggere come la stagione dell’emancipazione – l’acquisizione dei diritti. Proprio quei diritti che sono all’origine della grande stagione del movimento delle donne, quando partendo da sé, dalla loro storia e dalla loro condizione hanno individuato il tema della libertà e hanno proposto l’utopia del lavoro come scelta e azione di libertà. Il lavoro come libertà rimane un’utopia, ma come tutte le utopie tiene vivo il desiderio. Un desiderio che incontra molte difficoltà, se lo stesso movimento femminista si ferma alla soglia di una elaborazione sul lavoro.
Certamente ne abbiamo individuato le potenzialità, le ricchezze, le differenze, ma non siamo state capaci di elaborare una teoria capace di sorreggere le richieste di cambiamento. Di fatto questo nostro limite ha lasciato campo libero al modello dell’organizzazione del tempo e del lavoro che rimangono e vengono comunque anche oggi declinate a misura maschile. Lo stesso sistema pensionistico riconosceva di fatto implicitamente il doppio sfruttamento. Il lavoro non riconosciuto, la non esplicitazione della sua complessità permette, oggi, di sostenere, in nome della presunta parità, un sistema pensionistico unico non flessibile.
In questa incompiutezza di pensiero irrompono ora le giovani donne che progettano il loro lavoro e criticano quanto il movimento delle donne ha prodotto finora sul piano culturale e dei diritti. La scommessa su cui puntano e che vogliono vincere è quella di un lavoro come progetto pensato, perseguito, conciliato. Un progetto ambizioso, importante, che si scontra con le condizioni dell’economia, con il tentativo evidente di un arretramento sul piano dei diritti.
Tanto è vero tutto questo che le giovani precarie organizzate hanno coniato lo slogan: «Precarietà è contraccezione». È la precarietà che mette in discussione il diritto alla maternità, un diritto socialmente riconosciuto, ma che in realtà non trova alcuna cittadinanza nel lavoro. Un lavoro precario impedisce la maternità e diventa paradossalmente, e tragicamente, un metodo contraccettivo.
Ma anche la fotografia del lavoro femminile retribuito non è consolante: fa emergere il differenziale retributivo, di inquadramento e un pregiudizio sulla maternità che non arretra.
Per queste ragioni il lavoro come progetto richiede una parità non omologante e una misurazione della qualità che guardi alle competenze, alle relazioni, e infine un sistema previdenziale che, riconoscendo la disparità, riconosca la molteplicità dei lavori.
L’azione in questa direzione è urgente. Il peso di questa concezione del lavoro delle donne che caratterizza la situazione nel nostro paese, è lo stesso che determina anche sul terreno dell’economia, oltre che della cultura, l’arretratezza, la mancanza di crescita e di sviluppo nel quale oggi viviamo.
Susanna Camuso è segretario generale della Cgil
_______________________
Sinistra - Luciana Castellina
Se la domanda fosse relativa al rapporto uomini-sinistra, la risposta sarebbe facile: si tratterebbe di raccontare la storia del movimento operaio in tutte le sue varianti temporali, geografiche, ideologiche e politiche. Si potrebbe dire la stessa cosa per quanto riguarda le donne: anche loro, sia pure in un ruolo più marginale (o almeno così considerato) sono parte di questa stessa storia, sia pure vissuta in modi parecchio diversi.
E però, se si accosta la parola «sinistra» a quella «donne» si capisce subito che la risposta non è così semplice. Perché nel dire donne e sinistra è celata un’intenzione: le donne – si induce – sono in un particolare rapporto con la sinistra perché, non solo se e in quanto proletarie, ma indipendentemente dalla loro appartenenza di classe, sono oppresse da millenni da un sistema a dominio maschile. Perciò sono interessate a cambiarlo e, come è noto, la principale differenza fra sinistra e destra è che la prima si propone di trasformare lo stato di cose esistenti, la seconda, invece, di conservarlo così come è. Le donne, dunque, dovrebbero essere naturalmente di sinistra.
Così, però, come sappiamo non è. Anzi. Le donne sono state infatti a lungo considerate, e ancora assai spesso lo sono, decisamente di destra: conservatrici.
Quando ebbero finalmente il diritto al voto, nonostante le dichiarazioni ufficiali, gran parte delle forze progressiste non era affatto convinta si trattasse di una buona cosa. In Italia la decisione di battersi perché alle donne fosse riconosciuto tale diritto fu imposta da una leadership del Partito Comunista illuminata a una base più che riluttante. Le donne – erano convinti i più – avrebbero votato Democrazia Cristiana: perché più sottomesse all’autorità ecclesiastica; perché più ignoranti; perché la loro vita, non solo affettiva ma anche culturale e sociale, era legata all’immutabile microcosmo della riproduzione che nulla avrebbe potuto intaccare. Non a caso i manifesti elettorali della destra sono sempre sull’immagine della ‘donna madre’ che hanno puntato per strappare voti. Fino a legittimare l’idea che il cambiamento, e cioè la sinistra, fosse solo maschio.
Questa collocazione conservatrice è mutata col tempo. Le statistiche ci dicono che oggi, in Occidente, le donne votano quasi sempre più a sinistra degli uomini; o, almeno, molto più di prima. E anche negli altri continenti le donne sono in movimento, spesso alla testa delle rivolte sindacali. Perché è effettivamente la sinistra che ha interpretato i loro nuovi bisogni, emersi dai mutamenti economici e sociali, traducendoli in rivendicazioni concrete e in conquiste.
E così, naturalmente, il rapporto fra le prime associazioni di donne nate per rivendicare parità di diritti e la sinistra (prima i liberali) sono via via diventati più stretti.
Fino a una lacerazione grave, a metà degli anni ’70, intervenuta in forme più o meno aperte in tutta Europa, ma forse più vistosamente in Italia. Accade con l’avvento del pensiero femminista, che comunque resta ignorato e anzi deriso dalla destra e invece preso sul serio, sia pure gradualmente, dalle organizzazioni di sinistra. Il femminismo ribalta l’ipotesi emancipazionista, rifiutando l’idea che si tratti di dare alle donne gli stessi diritti e poteri e ruoli degli uomini, di ammetterle, alla pari, nel loro sistema.
Quel sistema, dicono, non è affatto neutro: è stato storicamente plasmato dai maschi, a misura loro e dei valori che ne sono derivati. Il fatto che abbiano presunto di imporlo a tutte e tutti come il solo possibile costituisce la più grande impostura della storia. Perché si fonda sull’idea – falsa – che i cittadini siano neutri, quando tutti sanno che bambini asessuati non ne nascono.
Un dato occultato dalla cultura e dalle Istituzioni. Se questo dato viene disseppellito, tutto – leggi, abitudini, valori – deve essere reinventato per rispecchiare questa differenza.
Il pensiero femminista esplode come una bomba, e come tutti i fenomeni realmente innovatori, con una forte carica estremista, necessaria a smantellare un simbolico maschile che ha penetrato l’intera società ed è entrato nella pelle delle stesse donne. Lo slogan diventa: basta con i travestimenti cui siamo state costrette per secoli se volevamo avere un qualche ruolo. Poiché le Istituzioni della sinistra – partiti e sindacati – così come gli uomini della sinistra individualmente, hanno partecipato all’imbroglio della neutralità, il felice rapporto donne-sinistra si inquina, poi si sfibra, in molti casi si spezza.
Le donne hanno cessato di vedere la loro affermazione come legittimazione all’interno del mondo costruito dai maschi, la loro aspirazione non è più quella di «essere come gli uomini» e perciò di reprimere la propria differenza, ma invece di darle evidenza e riconoscimento.
Il processo è in atto, contraddittorio, non univoco nelle sue analisi e conclusioni, vissuto e interpretato in modi diversi da ciascuna. Ma inarrestabile. Ha già prodotto un dato inedito: l’orgoglio femminile e una inedita sicurezza, e non è poco.
E però in questi anni il femminismo ha subito un andamento carsico, è stato certamente meno appariscente di quanto fu alle origini quando divenne anche politicamente dirompente e visibile. In qualche modo un dato scontato: una rivoluzione prende più tempo di una riforma. E infatti, proprio quando l’emancipazione veniva contestata dal femminismo, questa è paradossalmente avanzata: nonostante le disparità, sono molte di più le donne entrate nel mercato del lavoro, nelle università, nella ricerca scientifica, nella produzione artistica. Potremmo dire che si è verificata una «rivoluzione passiva» come risposta al fenomeno eversivo del femminismo: il sistema neutro-maschile ha accolto e integrato quanto di più indolore veniva portato dalle donne, ma ha rigettato il resto, la loro critica radicale, evitando così di dover ripensare l’intero modo di operare della società per adattarla ai tempi, ai modi, ai valori femminili. (Un solo esempio, emblematico: le donne manager sono aumentate del 30%, ma nella categoria solo un terzo di loro ha figli, a differenza del 95% dei loro colleghi maschi.)
Nonostante l’acquietante gattopardismo del sistema, la partita donne/sinistra non è tuttavia affatto chiusa. La sinistra più sensibile ha accusato il colpo, i suoi maschi sono essi stessi entrati in crisi perché la loro identità patriarcale è stata scossa, non sanno più chi sono da quando hanno capito di non poter rappresentare l’universale umano, ma di essere, dell’umanità, solo una parte. Anche per questo reagiscono spesso con la violenza.
I più avvertiti capiscono che devono ripensare daccapo il loro progetto. Resta il fatto che sebbene non più naturalmente di sinistra, le donne sono più sovversive. Lo sono state sempre, ben prima che la sinistra esistesse: dalle amazzoni alle streghe. Proprio perché alcune avevano capito che il mondo non era stato costruito a loro misura. Per questo sono state bruciate. Non a caso il primo slogan del movimento femminista, più che alla sinistra è alle eretiche per eccellenza che si è richiamato: «Tremate, tremate, le streghe son tornate».
Luciana Castellina, politica e giornalista,
dirigente dell’Udi, è stata parlamentare italiana
ed europea. È fra i fondatori nel 1969 del gruppo
del Manifesto e dell’omonimo quotidiano
|