|
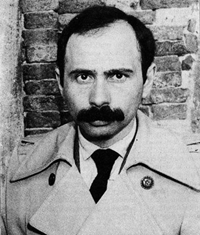 La vicenda umana e professionale
La vicenda umana e professionale
di uno dei padri fondatori del Sindacato
di Polizia. Un uomo che ha pagato
con la vita la coerenza delle proprie idee
Stiamo vivendo periodi in cui l’etica è calpestata ogni giorno da episodi indegni per chi ricopre cariche pubbliche, non ultima la voragine della Regione Lazio con la ex sindacalista Polverini che, non vigilando sui milioni di euro che le danzavano attorno, ha ritenuto solo tardivamente di dimettersi. Giusto in Italia accadono tali episodi che in un normale Paese democratico solleverebbero le masse e sarebbero immediatamente stroncate da regolamenti vigenti.
Perché questo riferimento iniziale? Perché in questi giorni, rimettendo a posto alcuni faldoni del Movimento, poi Siulp, ho adocchiato una cartella col titolo “Caso suicidio Trifirò”. Immediatamente una serie di brividi mi hanno consentito di andare indietro con la memoria avendo, comunque, sempre presente questa figura di collega sindacalista degli inizi della lotta per la Riforma e la sindacalizzazione.
Mi corre l’obbligo di spendere parole per questa splendida figura umana che ha pagato un prezzo troppo grande per la sua etica e la sua presenza integerrima. Tornando indietro nel tempo, negli anni ’80, era stata introdotta la legge Reale, che permetteva un “disinvolto” uso delle armi, che aveva purtroppo mietuto vittime innocenti ai posti di blocco e in altre azioni di Polizia. Come sindacato avevamo sottolineato che condotte eccessive avevano portato a morti innocenti di persone fuggite a un controllo a posti di blocco o ad alt della Polizia.
Nel Siulp si era sviluppato un ragionamento volto a evitare eccessi dato che la vita umana, sia dei poliziotti che delle persone eventualmente controllate, era assolutamente paritaria.
Gianni Trifirò, uno dei padri fondatori del Sindacato di Polizia, era tra quelli che con la propria condotta poteva essere considerato un poliziotto tipo, appartenente appunto a quella nuova Polizia che doveva nascere dalla Riforma 121/81 e che con la sua trasparenza, la sua disponibilità, la sua onestà intellettuale, fondeva totalmente questi principi dando un fulgido esempio.
Trifirò, come del resto il mondo sindacale dell’epoca, aveva sottolineato tali incongruenze per cui si era impegnato a che non si verificassero più episodi barbarici.
Purtroppo, un destino cinico e baro era dietro l’angolo e in un triste giorno dell’aprile 1986, mentre si trovava in servizio di prevenzione a Venezia, notò una coppia di pregiudicati a lui noti che destavano sospetto e tentò assieme a un collega di bloccarli. I due, una volta che si accorsero della presenza dei poliziotti, tentavano di darsi alla fuga dividendosi e Trifirò, inseguendone uno, gli intimò l’alt esplodendo un colpo di pistola in aria ma, inciampando quel colpo, ferì mortalmente l’uomo in fuga. Trifirò, in quel momento, presumibilmente, si vide passare davanti tutte le parole spese per evitare tali episodi e in un milionesimo di secondo capì che non avrebbe avuto scuse e si tolse dal mondo sparandosi un colpo alla tempia, cadendo riverso sul corpo della sua vittima.
Una tragedia shakespeariana si era compiuta con sangue innocente sparso per la via. Una tragedia assoluta per chi si era speso perché tali eventi non dovessero mai più accadere. Un uomo che aveva fondato assieme ad altri coraggiosi una strada per una riforma per una nuova Polizia pagava il prezzo più alto.
Franco Fedeli, fondatore di questa rivista a cui dobbiamo più di ogni altro il ricordo dell’uomo che per primo aveva intravisto la possibilità di creare un sindacato ai poliziotti, scrisse “la morte del vice sovrintendente Gianni Trifirò probabilmente, verrà archiviata come un incidente del mestiere, nessuno gli offrirà una medaglia, anche se dietro il suo gesto c’è una storia che dovrebbe servire come modello ideale a tutti gli operatori di polizia, a tutti coloro che credono ancora nel valori costituzionali e nelle garanzie che la legge offre ai cittadini di questa Repubblica.
In questa nostra epoca in cui l’uccidere diventa un sistema dove le stragi e l’odore di sangue non provocano orrore, dove da ogni angolo si odono rimbombi di guerra, il gesto di Gianni diventa emblematico: è un grido di allarme contro questa barbara filosofia: una risposta secca contro l’orrore della morte, un’affermazione di rispetto per la vita degli altri, un bene che non può essere tolto a nessuno. Grazie Gianni per questa nobile, civile lezione”.
Anche il giornalista Pier Vittorio Buffa - che lo aveva conosciuto assieme al capitano Riccardo Ambrosini nel corso della vicenda delle torture da loro denunciate a scapito del brigatista rosso Di Lenardo, inferte dai Nocs, arrestato per il sequestro del generale americano Dozier - spese parole nobili nei suoi confronti: “in quel momento, Trifirò deve aver pensato seguendo la sua rigida morale che non consentiva appelli, che lui stesso non poteva più far parte della ‘sua Polizia’, che non avrebbe più potuto insegnare ad un giovane arruolatosi che non bisogna tirare addosso a chi scappa. E che nemmeno al figlioletto avrebbe più potuto dire che la polizia non uccide. Poco importava per Gianni, in quel momento, che fosse stato un colpo accidentale, quello partito dalla sua pistola. La storia di quella polizia che lui aveva combattuto era piena di ‘colpi accidentali’”.
Mi corre l’obbligo di chiudere questo “momento del ricordo” di un compagno di lotta con le parole di Riccardo Ambrosini, il più grande e preparato collega che ho conosciuto e molto apprezzato nel corso della democratizzazione dell’Istituto di Polizia essendo sempre stato il mio Segretario generale sindacale preferito (se fosse stato eletto a tale incarico non saremmo ridotti a questo punto) e ahimè vituperato poi dai vertici stessi del sindacato che aveva contribuito a creare, dopo la vicenda delle denunce sul caso Dozier. Riccardo fu emarginato e dimenticato da chi invece doveva fargli ponti d’oro per la sua preparazione culturale e politica.
In quel tristissimo evento scrisse parole straordinarie: “Un fatto come la morte di Gianni è destinato ad attraversare il mio essere in tutte le sue stratificazioni, a ripercuotersi alla sua base, a toccare la mia stessa fine. La sua non è una morte qualsiasi; nemmeno la sua vita è stata una vita qualsiasi, ma nella sua morte c’è qualcosa di più per cui, mi pare, che questa non sia la fine dell’altra. Come ci sono tanti modi di vivere, ci sono morti delle interruzioni della vita, altre che ne segnano l’esaurimento.
La morte di Gianni mi pare che sia il completamento della sua vita e forse anche di più; egli apparteneva a quella cerchia di uomini che non si lasciano vivere ma costruiscono passo passo, giorno per giorno, la propria esistenza, la progettano, la verificano, la fanno maturare e non per difendersi meglio dalla realtà, ma per espandersi, per armonizzarsi con essa. Non è sempre facile in questo modo, anzi ci sono dei momenti in cui pare che sia impossibile.
La Polizia era diventata il fulcro della sua vita, non per astratto ideale ma perché ad essa era grato, perché ad essa doveva la comprensione di questo segreto; un segreto che tanti intellettuali e filosofi, con tutto il loro sapere, potrebbero invidiargli. Aveva sofferto il suo essere poliziotto perché voleva essere un uomo libero, ma aveva imparato ad essere poliziotto e uomo libero, anzi, una cosa in funzione dell’altra. Nel suo comportamento quotidiano, il rigore, perfino la pignoleria con cui svolgeva le sue funzioni, erano una prova di orgoglio, una sfida anche nei confronti degli altri. Era come se, silenziosamente, dicesse agli altri ‘vediamo se capite’”.
Anche noi, come individui e come società, dovremmo affrontare il secondo colpo, cioè quello che lo ha ucciso, quello che non si può evitare o assorbire nella quotidianità, il tempo delle digressioni, delle furberie, dei giochetti di prestigio con la realtà, si sta consumando: anche di questo ci avverte la morte di Gianni.
Lui, quando alzava la pistola contro se stesso, non pensava più a noi, al sindacato, alla Polizia e forse nemmeno a sé. Guardava avanti, entrava in quella dimensione in cui chi nega afferma, chi cade vince, e proprio cadendo vivifica il terreno su cui si sacrifica.
Così, grazie a lui, quando capiterà il nostro “secondo colpo” quello dell’inesorabile, forse faremo un passo avanti e non ci uccideremo”.
Le parole spese da Fedeli, da Buffa e da Ambrosini sono macigni che hanno un peso immane perché, pur essendo trascorsi ben 26 anni da quella gravissima perdita umana, sono di una attualità impressionante dato il peso specifico delle vicende che ci avvolgono con una tristezza e una indegnità quasi totale. Appunto per tali rilevanze questa vicenda era giusto riviverla e riportarla alla luce sebbene con un semplice ricordo scritto ma che almeno ci può fare perdere qualche minuto per rivivere un frammento di vita perduta così tragicamente.
Sono certo che, aver perduto prima del tempo Gianni Trifirò e più tardi Riccardo Ambrosini per una grave malattia, sia stato devastante per il sindacato che era appena nato ed era il primo per iscritti e ideali. Le strade percorse da queste dipartite sono state piene di inciampi, diciamo così, con la definitiva rottura dell’unità sindacale Cgil/Cisl/Uil che ha provocato una depotenzialità operativa e strategica raggiungendo un punto forse terminale.
Oggi, un silenzio assordante dei segretari generali di tutti i sindacati esistenti (che hanno raggiunto un numero esorbitante, ben una trentina), è stata la risposta ad un intervento a piedi uniti del capo della Polizia Manganelli, (il più pagato al mondo, ben 621.000 euro l’anno), che con una circolare assurda e anti-costituzionale ha proibito ai suoi sottoposti di prendere parola sul film Diaz del regista Vicari che narra la tragedia delle torture accertate alla scuola Diaz e al Reparto mobile di Bolzaneto a Genova nei giorni del G8.
Questo episodio che toglie il diritto primario ai poliziotti riveste una gravità inaudita ed è il più grave posto in essere dai vertici polizieschi dal varo della riforma 121/81 ad oggi.
L’ordine di Manganelli non contrastato con la immediata e necessaria forza così affonda l’art. 21 della nostra Costituzione per cui ci siamo avviati verso la fine dei principi sanciti dalla legge di riforma 121/81 che aveva aperto la via imprescindibile per una Polizia aperta, trasparente e professionale soprattutto a cominciare dai suoi massimi vertici.
FOTO: Gianni Trifirò
|