|
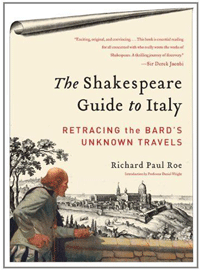 Nel nostro Paese non solo non si prende in considerazione
Nel nostro Paese non solo non si prende in considerazione
l’ipotesi che fosse Shakespeare, ma non si è fatto nessun
studio su questo emigrante che nel 1611 pubblica un dizionario
che contiene 74.000 parole italiane, traduce per primo
in inglese gli “Essais” di Montaigne e fornisce sempre in inglese
la prima versione integrale del “Decamerone”
A tre anni dalla pubblicazione in italiano e a due dalla versione inglese del mio libro (si veda www.johnflorio-is-shakespeare.com), mi sono chiesto perché l’Italia sia così ostile ad accogliere l’idea di uno Shakespeare di origine italiana.
Voglio condividere con voi queste mie riflessioni.
Malgrado siano stati abbastanza numerosi in Italia, una quarantina tra critici e anglisti, coloro che hanno ricevuto il libro, solo tre hanno risposto alle lettere di accompagnamento e nessuno ne ha scritto una recensione. Due specialisti si sono tuttavia pronunciati a favore di Florio ma l’hanno fatto di nascosto. Il primo è A.C. il quale privatamente, in una lettera a un amico comune, si è detto convinto dal libro. Il secondo è Dario Calimani che nel 2009 intervenendo in un Blog del New York Times ha commentato molto positivamente il libro che gli sembra quasi metter fine alla questione shakespeariana, tanto che Calimani invita interlocutori e lettori del blog a prenderne conoscenza.
Alla mia richiesta di rendere ufficiale la loro opinione, i due si sono dileguati.
Mi chiedo: perché in Italia c’è tanta diffidenza, indifferenza e disprezzo per la Shakespeare Authorship Question, ossia per il problema della paternità delle opere di Shakespeare? Che non sia una questione campata in aria appare evidente anche a un esame storico sommario. Per un’opera teatrale e poetica che è una delle massime se non la massima della modernità l’autore, evidentemente, latita. E non è normale, non è logico, non è giusto. Manca di vita, di carne, di psiche. Manca la persona di Shakespeare e mancano i documenti anche personali, gli scritti, le lettere, insomma l’espressione diretta e necessaria della personalità di uno scrittore. Manca di credibilità. La questione shakespeariana esiste, è una realtà storica e non il risultato di una cospirazione plurigenerazionale che durerebbe almeno dalla metà dell’Ottocento se non dall’epoca stessa di Shakespeare! È ragionevole dubitare della versione ufficiale. Un fatto che io trovo particolarmente sorprendente è il poco o nessun valore che gli specialisti (e dunque l’opinione pubblica che contribuiscono a formare) attribuiscono ai giudizi sull’identità di Shakespeare espressi da un numero elevato di grandi scrittori e scienziati moderni. Mi riferisco evidentemente ad autori come Henry James, Sigmund Freud, Charles Dickens, Mark Twain, Charlie Chaplin, Orson Welles e altri per cui il nome William Shakespeare sulle copertine dei libri non è sufficiente a identificare l’autore e che a «scuotere la lancia» ossia la penna, è stato qualcun altro. Autori questi, tutti degni di fede, reputatissimi, addirittura adorati, letti da moltitudini e insegnati nelle scuole ma che per questa loro posizione su Shakespeare invece vengono snobbati come si trattasse di cervelli balzani. A me sembra invece che la loro intelligenza, intuizione e sensibilità, insomma il loro genio, sia una garanzia molto più certa della pertinenza del loro giudizio di quella che ci viene dagli specialisti, siano essi dottori delle più prestigiose università anglosassoni, che si chiamino Bloom, Greenblatt o Shapiro.
Ma torniamo al rifiuto di Florio da parte italiana.
La prima ipotesi, per quanto riguarda il presente, è che la candidatura Florio è stata inflazionata o come si dice meglio in italiano, sputtanata recentemente dal libretto di un professore di scuola media di Ragusa che ha rilanciato nel 2000 il suo Florio Crollalanza (Shake-speare). La sua tesi folkloristica e l’approccio dilettantesco hanno avuto grande risalto nei media e non solo in Italia. Questo non deve sorprendere perché è una regola del mondo della comunicazione e dello spettacolo. L’attenzione dei media è inversamente proporzionale alla serietà e alla fondatezza delle tesi avanzate. Più una tesi sulla questione shakespeariana, ad esempio, è fasulla e destituita di fondamento, dunque «divertente», più i grossi media hanno tendenza ad accoglierla. Insomma i media fanno il loro mestiere: intrattengono senza rischiare di sovvertire le idee dominanti. E la storia tradizionale del bambinello di Stratford-Upon-Avon fa parte, come tante altre favole, dell’arsenale delle idee dominanti. Il rapporto intrattenuto con i due Florio, con il padre Michel Angelo ma soprattutto con il figlio John, dagli universitari italiani anzi, dall’intera cultura nazionale, meriterebbe un libro. Gli italiani, per istinto, stanno dalla parte di chi vince, che siano le armate francesi, le spagnole, le imperiali, Mussolini o Berlusconi. Siamo opportunisti, conformisti, collettivamente pavidi (individualmente temerari), insomma, servili, semplicemente perché anticamente e a lungo sottomessi. E agli italiani conviene più stare sotto lo Shakespeare di Londra che sotto quest’altro shakespeare nostrano, un compaesano come Giovanni Florio che troppo ci somiglia e che poi deprime con quel nome insopportabile che evoca sia la Targa che il marsala! Quanto sia diffuso quest’atteggiamento l’ho visto in Italia a partire dalla stretta cerchia familiare e amicale: un misto di stupore e non so di quale invidia e fastidio. Perché disturbare? Ma per chi ti prendi? La cultura italiana è perfettamente a suo agio con lo Shakespeare dominante, britannico e la semplice idea di sovvertire quest’ordine con un nome italiano la disturba! Come è mai possibile un tale paradosso, si chiederà chiunque appartenga a una cultura “nazionale normale”. La questione è complessa e anche contorta ma cercherò comunque di farmi capire. Gli accademici italiani “seri” si sono ben guardati, dall’Ottocento in poi, dal sostenere qualsiasi storia sulle origini italiane di Shakespeare temendo che una simile tesi li avrebbe resi ridicoli agli occhi dei colleghi delle prestigiose università inglesi e americane. Così i nostri professori, non solo hanno respinto sdegnosamente, con zelo superiore a quello dei britannici, le eventuali candidature italiche al ruolo di Bardo, ma sono arrivati a minimizzare anche l’influenza della cultura e della lingua italiane su Shakespeare e a snobbare totalmente John Florio eliminandolo dall’orizzonte dei loro studi. L’ultimo, a quanto mi risulta, è Alessandro Arcangeli, specialista di danza e passatempi rinascimentali che in un articolo del 2005 pubblicato in Francia, scrive: “Se alcune teorie più o meno recenti, secondo cui Florio sarebbe il vero autore del teatro di Shakespeare, possono far sorridere, e anche se è ragionevole immaginarsi che i due si frequentassero malgrado la cosa non sia documentata, e anche se l’identificazione di Florio come la persona che avrebbe ispirato alcuni personaggi di Shakespeare non è accolta da tutti gli specialisti, è tuttavia un fatto che Shakespeare ha utilizzato in modo ricorrente passaggi tratti dalle opere di Florio”. (traduzione dell’autore)
La tradizione continua, dunque. Quel lessicografo spaccone d’origine italiana che era John Florio non può essere Shakespeare! Se il terrore di passare per accattoni nazionalisti è stato certo una ragione importante che ha fatto dimenticare Florio, tuttavia ci sono altri motivi che rimandano, questi, ai meandri dell’ italica psiche. Al di là del motivo forse più forte, appunto l’ossequioso, colonizzato allineamento con il credo delle università anglosassoni che hanno etichettato John Florio come talentuoso lessicografo, un pedante Oloferne a cui il Bardo si è vagamente ispirato e basta, bisogna dire anche che gli universitari italiani non hanno mai avuto simpatia per questo strano italiano. Giovanni Florio infatti, è figlio di esuli, come dire profughi, sfollati, terremotati, emigranti, e chi emigra, ossia chi lascia l’Italia, non importa se quasi cinque secoli fa, si espone a una duplice e contraddittoria reazione critica e emotiva. Da una parte c’è la condanna morale rivolta a chi abbandona la patria, dall’altra c’è l’invidia per chi ce l’ha fatta a staccarsi, a liberarsi da una condizione ritenuta, allora come oggi, penosa. Se poi l’emigrato appartiene, come i Florio, alla minoranza di coloro che all’estero si sono resi illustri per le doti dello spirito, allora l’oblio è quasi una certezza. John Florio, anche prima di rivelarsi come l’autore delle opere di Shakespeare, era già percepito come un emigrante diverso, atipico, uno che aveva già tutto per non piacere agli italiani: non solo non era cattolico – dove cattolico vuol dire anche accomodante, portato al compromesso, trasformista – ma era anti-cattolico, protestante antipapista, figlio di uno perseguitato dall’Inquisizione di origine ebraica che invece di farsi spedire al rogo come Giordano Bruno, si era rifugiato in Inghilterra e ci era rimasto. John Florio avendo vissuto tutta la sua vita lontano dal commercio con gli italiani, arriva a pubblicare nel 1611 un dizionario che contiene 74.000 parole italiane raccolte in una quantità di variegatissima letteratura, dai classici del Trecento a tutto il Cinquecento, ma anche in opere scientifiche, tecniche, gastronomiche e militari! Un exploit geniale, di una modernità sorprendente, un risultato superiore al dizionario della Crusca che deve aver lasciato gialli di invidia i dotti italiani per quattro secoli! Tutto questo spiegherebbe bene l’antipatia che si è guadagnato in Italia. Se si pensa poi che è stato quest’emigrante a tradurre per primo in inglese gli Essais di Montaigne e, se non bastasse, a dare agli inglesi la prima traduzione integrale del Decamerone, allora si capisce come tanta virtù gli sia valsa l’oblio! In quattrocento anni nessuno, in Italia, ha scritto una monografia su di lui, quasi nessun saggio, né articoli importanti se si esclude quello di Spampanato nel 1923. E poi non esiste in Italia un premio di traduzione che porti il suo nome; né l’Istituto italiano di cultura di Londra gli è stato intitolato; né tanto meno è stata eretta una sua statua in qualche luogo significativo della capitale britannica o in una città italiana. Anche in occasione della ripresa di interesse e curiosità su John Florio nel 2005, sono studiosi stranieri, un tedesco, un americano e un inglese, a riaprire il discorso mentre gli italiani continuano a tenersi, tradizionalmente, a distanza di sicurezza.
Che ora poi questo scomodo emigrante diventi Shakespeare è assolutamente intollerabile. Un cambiamento rischioso. Un problema in più, un’immensa, imbarazzante eredità che richiederà un’autocritica e una celebrazione che nessuno avrà voglia di compiere. Gli italiani non amano le riforme e tanto meno le rivoluzioni e, ne sono convinto, la maggioranza di loro, a parte gli sfegatati, nostalgici nemici della “perfida Albione”, pensa che sia meglio che tutto resti com’è.
__________________
In viaggio con il Bardo
Chiunque legga l’opera di Shakespeare si rende conto che due suoi aspetti maggiori sono l’eccezionale creatività linguistica e la centralità dell’Italia e degli italiani. Richard Roe, avvocato californiano morto nel 2010, si è occupato di questo secondo aspetto e, non rassegnandosi all’idea sostenuta da quasi tutta la critica accademica che i drammi italiani (the Italian plays) fossero stati scritti a tavolino in Inghilterra, ha deciso di compiere una metodica ricerca sul terreno. La conclusione della sua appassionata e acutissima indagine è questa: chi ha scritto quel teatro aveva “una insolita e intima conoscenza dell’Italia” (an unusual, intimate, knowledge of Italy). Per circa 25 anni è venuto in vacanza in Italia con la moglie, percorrendo in lungo e in largo il nostro bel Paese con in mano il suo sgualcito Shakespeare tascabile. Così ha concluso sempre in modo definitivo e rigoroso che l’autore di quei drammi italiani non si è mai sbagliato né in storia, né in geografia, né in topografia. Richard Roe che non è stato il primo a sostenere che il Bardo doveva conoscere l’Italia, ha fatto ricorso anche alle analisi di studiosi come Edward Sullivan (1918), Ernesto Grillo (1949) Georges Lambin (1962), Noemi Magri (2004), i cui scritti egli cita in bibliografia ma purtroppo senza indicare nel testo i singoli contributi di ciascuno alla propria ricerca. Nel suo libro, il nome Shakespeare figura quasi solo nel titolo in copertina, poiché nel testo si parla piuttosto di “autore” (author) e commediografo (playwright). Insomma Shakespeare è colui che ha scritto quelle “opere italiane” chiunque egli fosse. A sbagliarsi sono stati per secoli gli arroganti e fatui dottori delle università, sia delle “prestigiose” anglosassoni sia delle nostrane succursali che hanno sorriso con condiscendenza di fronte alle ingenuità, invenzioni, errori del grande inglese sedentario. È stata ed è ancora l’opinione di quasi tutti, dai grossi shakespeariani di successo come Greenblatt, Bate e Shapiro ai più piccoli come McCrea e Marrapodi che hanno sempre sostenuto che Shakespeare aveva raccolto la sua materia italiana da libri, dai ricordi di nobili turisti inglesi e da italiani in visita o da stanziali come il nostro Giovanni Florio. Un aspetto specifico della presenza italiana in questi Italian plays è il carattere quasi furtivo, segreto ma anche intimo e personale di dettagli “italici” unici, disseminati nel racconto da uno che li ha vissuti o a cui sono stati vivamente trasmessi. Tutti segnali questi che all’analisi di verifica compiuta da Roe, appaiono implacabilmente veri e autentici, testimonianza irrefutabile di una esperienza diretta, di vita realmente vissuta e certamente non dallo Shakspere di Stratford. Esempi, a sfare: i viaggi via acqua sui canali e fiumi del Veneto-Lombardia, tra i porti di Milano e Verona e Padova; il pozzo di San Gregorio nei Due gentiluomini di Verona; il gabbano (gaberdine) di Shylock; le navi da carico di Antonio, il mercante di Venezia, che sono Argosies ossia affittate a Ragusa e my wealthy Andrew è un’ “Andrea Doria” affittata a Genova; Shylock che parla di a wealthy Hebrew of my tribe, mostrando così che l’Autore sapeva che c’erano varie etnie tra gli ebrei di Venezia; in Otello, la veste senatoriale (black gown) di Brabanzio; l’identificazione del luogo dove si ritrovano Otello e Desdemona: Sagittary ossia, via Frezzeria, etc. etc. Per me, di capitale importanza sono due termini che appaiono usciti dalla fucina linguistica di John Florio e confermano, ai miei occhi, che l’Italia di Shakespeare non è il paese visitato da un nobile turista inglese come il conte di Oxford, ma l’Italia conosciuta e sentita da un italiano d’origine. Il primo dei due termini è una parola latina inventata ad hoc per identificare il posto dove, nel Mercante di Venezia, Porzia deve incontrare Baldassare: Tranect. Che non è un posto ma un sistema meccanico che permette di trasferire (trans-nectere) le imbarcazioni dal Canal di Brenta alla Laguna.
|