|
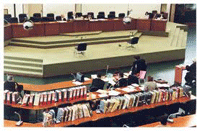 I tentativi negli ultimi dieci anni di riformare il codice penale sono sostanzialmente falliti; nel tempo la riforma si è sempre più spostata verso la politica e i suoi problemi. Intanto i cittadini vivono una realtà di continui divieti, dove però il giudizio arriva solo per i più deboli
I tentativi negli ultimi dieci anni di riformare il codice penale sono sostanzialmente falliti; nel tempo la riforma si è sempre più spostata verso la politica e i suoi problemi. Intanto i cittadini vivono una realtà di continui divieti, dove però il giudizio arriva solo per i più deboli
«Il diritto penale è una politica», e si potrebbe aggiungere di altissimo livello sociale. A sostenerlo è l’Avvocato Rodolfo Bettiol, professore associato di Procedura Penale all’Università di Padova. Al di là dei dissidi tra la magistratura e la politica, oggi la cultura penalistica italiana, «che per troppo tempo – scrive Maurizio Masi, dottore magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia – ha coltivato un amore platonico per il sistema», dovrebbe farsi carico di una riforma seria del codice.
Il professore Tullio Padovani, Ordinario di Diritto Penale presso la Scuola superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, in una prolusione si è posto il seguente interrogativo: «come mai il codice penale Rocco è, formalmente, lo stesso dell’VIII Anno dell’Era fascista (1930)?»
Il diritto penale, in termini semplicistici, è il complesso delle norme che descrivono i reati e le pene da essi derivanti. Lo Stato, proibendo determinati comportamenti umani (reati), avvalendosi della minaccia di una sanzione (pena), cerca di tutelare i valori fondamentali di un popolo. Uno dei nodi è proprio qui: i valori di un popolo (o per meglio dire le priorità) in parte si modificano con il tempo, e il codice dovrebbe modificarsi di conseguenza. Per capire meglio è necessario fare alcuni esempi, per via di norme desuete la polizia spesso è costretta a controllare le seguenti attività: controllo delle autorimesse, degli ascensori, controlli su rappresentazioni teatrali, cinematografiche, feste da ballo, alberghi, iscrizione dei portieri, arte tipografica, litografica e fotografica. Controllo anche sul commercio di cose antiche, di mestieri girovaghi (facchino, cocchiere, noleggiatori in genere) che sono tenuti ad essere iscritti in un apposito registro che ha validità su tutto il territorio nazionale. Cura inoltre il rilascio di pareri sulle domande per videogiochi, radio, tv, rilascio licenze per sale gioco, autorizzazioni per i giochi leciti di carte, richieste di occupazioni del suolo pubblico. In un periodo storico in cui le risorse per la ‘sicurezza’ vengono diminuite ad ogni finanziaria, è possibile pensare al controllo dei portieri (eredità del fascismo, utile per il controllo sociale)? Vista la continua domanda di giustizia e soprattutto legalità, forse è arrivato il momento che in Italia si ricominci a discutere di riordino del ‘sistema giustizia’ e in modo più specifico del codice penale.
Ottant’anni e siamo ancora fermi al Codice Rocco
Ventotto anni dopo l’Unità il Ministro della Giustizia, Giuseppe Zanardelli, promulgò il primo codice penale italiano. Il 1° gennaio 1890 entrò in vigore. Il codice penale attuale, però, è il frutto di un percorso legislativo durato 5 anni, dal 4 dicembre 1925, giorno in cui venne pubblicata la legge n. 2260, con la quale il governo ricevette la delega ad emendare il codice penale allora in vigore, al 19 ottobre 1930 giorno in cui venne promulgato il codice, realizzato tecnicamente sotto la direzione del Manzini, e con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1930. Il regio decreto viene generalmente chiamato Codice Rocco.
Nonostante abbia subito delle modifiche nel corso degli anni, anche in seguito alle sentenze della Corte costituzionale, il Codice penale del 1930 è tuttora in vigore. Numerose sono state le commissioni di studio che hanno redatto relazioni ed articoli per l’approvazione di un nuovo codice penale e il Codice Rocco è stato ampiamente criticato da più parti politiche. «La chimera del riformismo codicistico – spiega Tullio Padovani – è inseguita sin dalla caduta del regime fascista, in seguito alla quale si scontrarono in dottrina due tesi: da un lato si riteneva opportuno segnare una radicale discontinuità con gli ideali totalitari, rimettendo le lancette dell’orologio sul codice Zanardelli del 1889, codice dignitosamente liberale; dall’altro lato uomini illustri, tra cui Calamandrei, rilevando un’impossibilità pratica di un ritorno sic et simpliciter alla codificazione penale prefascista, sosteneva la bontà tecnica del codice e ritenevano che nel breve periodo sarebbe bastato espugnare dal codice le escrescenze più odiose, quali – a titolo esemplificativo – la pena di morte e la mancanza delle attenuanti generiche, ed aspettare la riforma globale, dall’essenza democratica, che sarebbe certamente seguita a breve». Sono passati 64 anni ed i numerosi progetti di riforma globale del codice penale (da quello Gonnella del 1945 a quello Moro del 1985, da quello Gonnella II del 1968 ai progetti degli ultimi anni) sono falliti.
Tentativi di riforma, un continuo rincorrersi
Nella sostanza del Codice Rocco del 1930 rimane ben poco. Modifiche settoriali, abrogazioni, inserimenti e interventi della Corte costituzionale hanno reso il Codice un semplice involucro, una struttura che cerca di mantenere salde diverse filosofie. Quando si tratta di legiferare, infatti, «il legislatore – scrive Padovani – è costretto a misurarsi con se stesso e con le istanze sociali, a mettere le carte (i valori) sul tappeto, dando un peso differenziato e gerarchizzato ai vari valori in gioco (vita, libertà, patrimonio…). Pertanto – conclude il professore Padovani – se il codice è di per sé necessario, perché socialmente e politicamente si è rinunciato ad una sua riforma?» Come abbiamo già accennato alcuni tentativi sono stati fatti, e il 1988 rappresenta un anno cruciale nel processo riformatore del codice penale. In quell’anno, infatti, non solo vedeva la luce il nuovo Codice di rito (la cui entrata in vigore poneva un problema di compatibilità con il Codice preesistente), ma veniva anche istituita una Commissione (presieduta dal Prof. Pagliaro) incaricata, dall’allora ministro della Giustizia Vassalli, di redigere uno schema di legge-delega da sottoporre successivamente al Parlamento. Oltretutto il dibattito sulla riforma fu reso più serrato dall’approvazione dei nuovi codici penali francese e spagnolo. Anche le influenze dell’Unione Europea sul diritto interno e la prospettiva di un diritto penale comune europeo incisero molto sulla nascita della commissione. Lo schema preparato «costituiva il punto di approdo delle principali posizioni assunte dalla dottrina, a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, sulla riforma del codice penale. Il ‘progetto Pagliaro’ oltre a rappresentare la piattaforma dogmatica in cui si riconosceva la dottrina prevalente, costituisce il più importante tentativo di riforma globale del Codice Rocco in grado di muoversi secondo coordinate improntate ai principi costituzionali e agli orientamenti dei principali sistemi penali europei. Naturalmente, non sono mancate le critiche ai lavori di quella commissione». Tra le principali novità proposte c’erano: la riaffermazione della centralità del codice penale, la previsione di uno specifico Libro per le contravvenzioni (ridotte nel numero e distribuite nei quattro libri di parte speciale presenti nel progetto), la limitazione della legislazione extra-Codicem, inserendo nel Codice numerosi reati attualmente fuori (reati bancari, fallimentari, sul lavoro), l’introduzione di nuovi reati (lo stupro di gruppo, la molestia sessuale, il genocidio), la reintroduzione del plagio, l’abolizione della preterintenzione, la vicarietà tra pene principali e accessorie, la sostituzione dell’arresto con la semidetenzione per le contravvenzioni e l’ampliamento del ricorso alle sanzioni sostitutive. Verso la fine del 1991 i lavori giunsero al termine, nel 1993 il Guardasigilli del governo Ciampi, Giovanni Conso, decise di inviarlo per osservazioni e pareri alle facoltà giuridiche, ai consigli giudiziari e agli ordini forensi. Una delle prime critiche mosse non riguardava il merito ma piuttosto il metodo: il sistema della delega, scelta dettata dalla lentezza dei lavori parlamentari, che non avrebbe reso possibile una approvazione in tempi ragionevoli di un testo così lungo e complesso. «La conclusione dei lavori della Commissione Pagliaro – racconta Padovani – coincise con la profonda crisi politico-istituzionale del 1992, la quale non consentì allo schema di legge-delega di avviare l’iter parlamentare previsto dalla Costituzione».
Sulle fondamenta del progetto di Pagliaro, nel 1994, nel corso della XII legislatura, fu istituito presso la Commissione giustizia del Senato un comitato per la riforma del codice penale, il quale presentò un disegno di legge che ebbe come primo firmatario il senatore Riz. In questo progetto tornarono, scrive Padovani, «i temi affrontati e risolti con lo schema di legge-delega del ‘92: la rilevanza costituzionale dei beni giuridici, i limiti entro i quali codificare la legislazione speciale, la riduzione del diritto penale all’extrema ratio, l’opportunità o meno di distinguere tra delitti e contravvenzioni, l’eliminazione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva. Ampio spazio dedicava la relazione alla disciplina delle scriminanti, con particolare riguardo al tema del consenso nelle contese sportive e nei trattamenti medici, e alla disciplina delle circostanze». La parte conclusiva della relazione si soffermava sui problemi tra diritto penale e diritto comunitario. Per Riz lo schema Pagliaro era stato troppo generico sul problema della preminenza delle norme comunitarie sul diritto penale (limitandosi ad affermare che, agli effetti della tutela penale, bisognava assimilare gli interessi della Comunità europea a quelli propri dello Stato).
«Al di là degli aspetti sostanziali – conclude Padovani –, ciò che colpisce del progetto Riz è il metodo. Un metodo tradizionale, già noto per la sua incapacità di compiere scelte di ampio respiro che conducano ad un sistema riformato che sia logico e coerente. Trattando della sola parte generale del codice, veniva meno l’approccio sistemico alle riforme, ripetendo così l’errore dei progetti di riforma passati che si erano illusi di poter modificare la sola parte generale (l’unica dove i margini di accordo erano più ampi), per riformare la parte speciale in un secondo momento; come se i principi generali racchiusi nel libro I possano davvero essere modificati o creati ex novo senza sapere rispetto a quali fattispecie criminose dovranno poi trovare applicazione». Il progetto fu giudicato «disorganico» e rivolto metodologicamente al passato.
Nel 1997 la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali inseriva nella propria agenda anche i temi relativi alla giustizia, concentrandosi, a differenza dei precedenti tentativi, sulla questione della ‘separazione delle carriere’ tra magistratura requirente e giudicante. Il 1 ottobre 1998 il Ministro della Giustizia Giovanni Flick – si legge sul sito del Ministero della Giustizia – «ha nominato una Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dal Prof. Carlo Federico Grosso, e composta da cinque professori universitari (Proff. Francesco Palazzo, Paolo Pisa, Domenico Pulitanò, Sergio Seminara, Filippo Sgubbi), da quattro magistrati (Dott. Giovanni Canzio, Giovanni Silvestri, Giuliano Turone, Vladimiro Zagrebelsky), da quattro avvocati rappresentativi di organismi ufficiali della avvocatura (Avv. Fabrizio Corbi, Ettore Randazzo, Filippo Siciliano, Giampaolo Zancan e chiamata ad operare con la partecipazione del Capo di Gabinetto, del Capo dell’Ufficio Legislativo e del Direttore Generale degli Affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia. Tale Commissione aveva il compito di provvedere, entro il 30 giugno 1999, alla stesura di un documento che approfondisse i temi della riforma del codice penale, tenendo conto dei lavori svolti da Commissioni Ministeriali e Parlamentari (Commissione Pagliaro, Comitato Riz), dei provvedimenti all’esame del Parlamento, delle elaborazioni in corso presso il Ministero su aspetti collegati, della più recente elaborazione della dottrina e della legislazione penale europea».
Dopo due anni di lavoro la Commissione Grosso ha consegnato al Ministro della Giustizia Oliviero il testo di un documento nel quale «erano tracciate le linee di una possibile riforma della parte generale del codice penale ed impostati i problemi di necessario coordinamento con la parte speciale e la legislazione penale speciale».
La riforma ebbe un’impronta garantista, figlia della tradizione liberal-democratica. «Questo obiettivo – viene spiegato nel sito del Ministero – è stato perseguito innanzitutto prestando grande attenzione alla realizzazione dei principi di tipicità e certezza nella disciplina dei presupposti della responsabilità penale: non soltanto attraverso la enunciazione delle tradizionali norme generali di garanzia (principio di legalità, principio di stretta legalità, irretroattività della legge penale), ma soprattutto attraverso una definizione più tassativa di istituti tradizionalmente affidati ad una ampia discrezionalità giudiziale». Proprio l’intervento sulla disciplina della pena, e soprattutto della sua applicazione in concreto, oggi andrebbe potenziato. Inoltre andrebbe ragionevolmente ridotta la discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena, oggi smisuratamente ampia. Basterebbe ridurre la forbice fra minimo e massimo edittale di ciascun reato.
La Commissione bicamerale del ‘98 è naufragata in seguito ai numerosi contrasti che, specialmente sulla forma di governo, sempre più contraddistinguevano i lavori, travolgendo anche i pochi margini d’accordo esistenti.
Con il secondo Governo Berlusconi, il 23 novembre 2001, si insedia una nuova commissione, presieduta da Carlo Nordio, che ha il compito di presentare al Ministro della Giustizia il progetto di legge delega per un nuovo codice penale. Nel provvedimento si rileva la necessità di procedere ad una riforma che – come riportava Italia Oggi – prevedeva «poco (pochissimo) carcere, senza più multe ma con sanzioni interdittive e con pene accessorie che comprendono anche il divieto di emettere assegni o utilizzare carte di credito. E il divieto di utilizzare Internet». Anche l’ergastolo veniva limitato ai casi più gravi «per effetto del meccanismo di compensazioni tra circostanze aggravanti e attenuanti, sarà applicato solo ai casi in cui non vi è neanche una circostanza attenuante». Veniva anche introdotta una nuova causa estintiva della pena: il perdono giudiziale. La riforma del codice – veniva spiegato dall’ex magistrato veneziano, il ministro Roberto Castelli alla conferenza stampa – prevede un’ampia depenalizzazione. I reati di opinione si sarebbero trasformati in reati comportamentali. Si studiava in particolare la modifica dell’articolo 241 del codice vigente, quello relativo agli «attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato».
Tra i profili di maggiore innovazione del codice penale, proposti dalla commissione Nordio spiccava la riforma del sistema sanzionatorio. «Il nuovo modello – scriveva Italia Oggi – è basato, in linea generale, sull’eliminazione della pena pecuniaria (mantenuta esclusivamente per i reati di competenza del giudice di pace) e dell’arresto (in dipendenza dell’eliminazione di tutte le contravvenzioni), e su un sistema in cui la reclusione da una parte diventa centrale come unità di misura della gravità del reato e dall’altra diventa parametro per la conversione in altra pena detentiva, interdittiva, ablativa (la confisca) o prescrittiva (per esempio, l’allontanamento dalla famiglia o l’espulsione dello straniero con divieto di reingresso) che spetta al giudice di cognizione. Con l’obiettivo dichiarato di prevedere il carcere come estrema ratio e di puntare a un sistema di sanzioni meno afflittive ma effettive, garantendo il principio costituzionale del fine rieducativo della pena». Peccato che i Governi Berlusconi, in materia di legalità e sicurezza, si sono sempre comportati in modo quantomeno contraddittorio. Prima legiferando duramente contro gli immigrati (la famosa legge Bossi-Fini), e poi tagliando i fondi alle forze di polizia.
Durante l’ultimo governo Prodi, ministro della giustizia Clemente Mastella, è Giuliano Pisapia (allora del Prc) a cimentarsi in un nuovo progetto di riforma del codice penale. «Un lavoro durato otto mesi - viene riportato dall’Ansa - con riunioni a cadenza settimanale della Commissione composta da 19 membri, tra professori, avvocati e magistrati, oltre al Comitato composto da altri quattro membri, professori provenienti da diverse aree geografiche del Paese».
Durante un convegno di tre giorni a Siracusa vengono descritti i cardini della nuova proposta. Durata dei processi: si cerca di razionalizzare i tempi della giustizia «introducendo, pena la prescrizione del reato, termini massimi per l’esercizio dell’azione penale e per l’emanazione delle sentenze». Si propone l’abolizione dell’ergastolo prevedendo «un sistema di verifiche periodiche sulla personalità del condannato per rendere più seria l’applicazione dei benefici, come la liberazione condizionale, la semilibertà». Per quanto riguarda la legittima difesa, si cerca di allargare le maglie a vantaggio della persona e della vita a discapito della sfera patrimoniale. Si introduce tra le «cosiddette cause soggettive di esclusione della responsabilità, l’eccesso dei limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, l’integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa». Per i recidivi vengono aggravate le pene, previsti anche aumenti di pena per tutti i reati con finalità terroristiche o mafiose per agevolare associazioni terroristiche o mafiose. E ancora, «carichi sanzionatori più consistenti per chi delinque per futili motivi, per chi abusa dei disabili o delle persone in stato più deboli per gli anziani e per chi delinque usando armi improprie come la siringa».
La riforma del codice penale messa a punto dai 19 esperti della Commissione Pisapia, inoltre, fa cadere la distinzione tra delitti e contravvenzioni: resta come unica categoria quella dei reati. «Fondamentale il principio di offensività: non sarà punibile un fatto se a seguito della sua commissione non c’è stata una effettiva lesione del bene o dell’interesse protetto dalla norma». «Cambia anche il sistema sanzionatorio: oltre al carcere, vengono previste anche le pene interdittive, prescrittive e la detenzione domiciliare. Nella sentenza di condanna, il giudice potrà disporre pene alternative al carcere (mentre nell’attuale sistema è il tribunale di sorveglianza a stabilirle). La previsione di un maggiore ricorso alle sanzioni alternative al carcere dovrebbe avere come effetto una riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, dove assistenti sociali e agenti penitenziari potranno lavorare con l’obiettivo di più sicurezza e più reinserimento sociale».
Come molti ricorderanno il governo Prodi cadde anche per colpa del ministro Mastella, il progetto di Pisapia quindi non vedrà mai la luce.
Il confronto con l’esperienza di altri paesi europei
La situazione italiana è oggi «atipica» rispetto a quella europea. In effetti - scrive Enrico Ambrosetti (Ordinario di diritto penale all’Università degli Studi di Padova) -, «nel corso dell’ultimo dopoguerra si può dire che quasi tutti i paesi europei hanno proceduto ad abbandonare codici penali che risalivano, in alcuni casi, addirittura ai primi anni dell’Ottocento». A tale riguardo, va peraltro riconosciuto che il cammino per questa riforma non è stato né facile, né veloce. È doveroso sottolineare che l’adozione di un nuovo codice penale costituisce «un momento fondamentale per l’ordinamento dello Stato e in quanto tale richiede una forte coesione fra tutte le forze politiche. Tale giudizio trova conferma proprio nelle vicende europee». Alcune distinzioni, comunque, sono doverose. Alcuni stati europei, ad esempio, ancora oggi non hanno nel loro ordinamento un codice penale. I paesi figli della tradizione inglese, dove il diritto penale si è originariamente formato sulla base delle consuetudini e delle decisioni dei giudici, vivono al loro interno un dibattito «sull’opportunità di introdurre un codice penale, ma finora i progetti non sono stati accolti dai Parlamenti nazionali. Per quanto riguarda gli altri Paesi Europei, si deve compiere un’ulteriore distinzione. Alcuni fra essi hanno proceduto ad iniziare un processo di riforma penale immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. È questo il caso della Germania e dell’Austria, per le quali le tragiche vicende belliche imponevano l’adozione di un codice pienamente rispettoso dei principi dei nuovi Stati democratici». A metà degli anni Settanta la Germania era dotata, per lo meno per la parte generale, di un nuovo codice. Tuttavia, si deve rilevare che il processo di riforma è proseguito anche successivamente a tale data. In altre nazioni europee - spiega Ambrosetti - « il processo di riforma è iniziato molto più tardi e si attuato solamente negli anni Novanta. Intendo qui fare riferimento alla Francia, ma anche alla Spagna ed al Portogallo. Le ragioni che hanno determinato questa maggiore lentezza sono le più varie. In alcuni casi - Spagna e Portogallo - è solamente con l’instaurarsi di un regime democratico negli anni Settanta che è potuto iniziare un processo di riforma penale. Per la Francia è stato, invece, il forte attaccamento alle proprie tradizioni giuridiche a rendere difficile l’adozione di un nuovo codice». Il caso francese è quantomeno emblematico, fino al 1994 era infatti «in vigore il Codice penale napoleonico che era stato approvato nell’ormai lontano 1810. Solamente sotto la presidenza Mitterand il parlamento francese è stato in grado di procedere all’adozione del nuovo Code pénal».
Nei Paesi ‘ex comunisti’, poi, vigevano codici penali ispirati ai principi del socialismo reale. «È stato quindi inevitabile che con l’avvento di regimi democratici venissero introdotti codici penali corrispondenti ai principi di uno Stato di diritto».
In sostanza possiamo constatare come gli altri Paesi, a differenza del nostro, oltre a discutere e a parlare di riforme, riescano anche a portarle a compimento. La dottrina italiana finisce così, dopo anni di dibattiti e di vane speranze di riforma, con l’assumere, paradossalmente, la posizione di chi dal percorso riformatore che si è svolto in Europa ha tutto da apprendere.
Proposte per un dibattito pubblico
Nel corso delle varie legislature i Parlamenti italiani che si sono succeduti hanno avuto diverse difficoltà ad approvare un nuovo codice. L’instabilità delle maggioranze parlamentari e delle coalizioni di governo con i conseguenti scioglimenti anticipati delle Camere hanno impedito quel complesso lavoro che deve precedere l’approvazione di un testo legislativo di tale importanza. E d’altro canto, «non può considerarsi casuale il fatto che dall’entrata in vigore della Repubblica vi sia stata la promulgazione del solo codice di procedura penale. Tutti gli altri - civile, procedura civile, penale - sono ancora risalenti al regime fascista».
Negli ultimi decenni, quindi, si sono fatte solo delle rifiniture utili a rendere il sistema penale meno pericolante e fatiscente. La riforma del Codice Rocco sembrerebbe dipendere, oggi più che mai, dalle concrete possibilità che il nostro paese ha di ritrovare la funzionalità e la stabilità politica degli altri paesi europei. Ma è solo questo il problema? Dalla lunga lista di tentativi descritti emerge come il ricorso ad una sempre più frenetica attività di riforma, lungi dal portare al risultato di un sistema penale moderno, idoneo cioè a tutelare la società dall’attività criminosa ed allo stesso tempo a garantire al reo i diritti fondamentali di uno Stato di diritto, conduce a scelte di politica criminale spesso incoerenti e ingiustificate. Un esempio valga per tutti. Come è noto, la legge n. 251/2005 - c.d. legge ‘Cirielli’ - ha introdotto una nuova disciplina della recidiva. Il tratto caratterizzante può essere individuato nella prospettiva di un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti del recidivo, e cioè di chi già condannato per un delitto non colposo ricade nel reato. Tale maggior rigore sanzionatorio si manifesta non solamente negli aumenti di pena e nella previsione di un’ipotesi di recidiva obbligatoria, ma anche in ordine ad altri istituti (circostanze attenuanti generiche, continuazione, prescrizione del reato e benefici penitenziari). Ebbene, tale scelta viene sostanzialmente a smentire quella che era stata compiuta dal legislatore nel 1974, quando il regime della recidiva era stato trasformato da obbligatorio a discrezionale, attenuando così il rigore dell’originaria disciplina del Codice penale.
Assistiamo forse all’avverarsi della citazione di Solone (politico greco del 640-560 a.C.)? «Le leggi sono come ragnatele: quando qualcosa di leggero e di debole ci cade sopra, la trattengono, mentre se ci cade una cosa più grande, le sfonda e fugge via».
Il sistema penale ‘moderno’ dovrebbe perseguire come finalità principale la prevenzione generalizzata, «ponendosi non come mezzo di risoluzione (preventiva) dei conflitti sociali - spiega Zaffaroni - , bensì come sistema di prevenzione (generalizzata) della conflittualità sociale. Il suo fulcro d’azione si colloca non nel danno o nel pericolo, ma nel rischio; il diritto penale ‘moderno’ imposta la dinamica del conflitto non più sulla separazione antitetica fra due ‘mondi’ diversi, ma sul patteggiamento fra autore e vittima». Il diritto penale oggi quindi si vede sempre più attribuire una funzione moralizzatrice facendone uno strumento di pedagogia politico-sociale. Oltretutto, scrive Paliero, «non è più in grado di attirare al suo interno, con un immane processo di semplificazione, tutte le figure delittuose che già stanno fuori e che continueranno a prodursi fuori dal codice». È lecito allora chiedersi: è davvero necessario un codice?
A questa domanda prova a rispondere il Prof. Tullio Padovani. «Da una parte, difatti, risulta quasi impossibile pensare ad una riforma dell’intero codice nel quadro della società complessa in cui viviamo, società postmoderna che ha fame di regole, e si configura sempre più come una società disciplinare; d’altra parte l’idea di mettere tutto in un codice si è dimostrata storicamente perdente, per cui le leggi speciali e settoriali verosimilmente si moltiplicheranno ancora. Non basterebbe, quindi, tutelare con leggi settoriali ‘la vita’, ‘il patrimonio’, ecc. e lasciare al giudice il compito di applicarle»?
Si dovrebbero quindi potenziare le capacità di risposta alle esigenze di prevenzione generale (capacità dissuasiva dal commettere reati) e speciale (rieducazione, che ha trovato un forte riconoscimento nelle stesse norme sulla commisurazione della pena), nel rispetto dei principi di proporzione e di ragionevolezza delle pene e delle garanzie dei diritti della persona. Per aumentare la capacità dissuasiva si potrebbe pensare ad inserire l’obbligatorietà della denuncia: questo è solo un esempio per aprire un dibattito. Magari iniziando a selezionare una serie di reati di rilevanza sociale. Nel caso del racket, l’obbligatorietà della denuncia potrebbe portare alla creazione - soprattutto in quelle zone del Sud Italia dove il fenomeno è diffusissimo - alla creazione di una ‘massa critica’ tale da impedire ritorsioni mirate, costringendo così anche le Istituzioni ad intervenire in modo concreto. Il solo fatto poi di censire in modo preciso e localizzato il mondo del pizzo diventerebbe un utile strumento di prevenzione.
Altro nodo caldo, affrontato da quasi tutte le proposte di riforma, è la discrezionalità del giudice. Si dovrebbe continuare a diminuire la forbice tra minimi e massimi edittali, riducendo magari qualche circostanza speciale ormai anacronistica e aumentare le aggravanti per i recidivi, ricordandosi sempre che un sistema penale caratterizzato da cautela nel ricorso alla reclusione e da un elevato affidamento in pene diverse non è affatto per definizione un sistema penale più debole.
Un giorno, superato il berlusconismo, il nostro Paese forse sarà pronto ad affrontare la riforma del codice penale guardando al mutato scenario sociale e alle parole di Aristotele. «La legge è ordine; e una buona legge è un buon ordine».
|