|
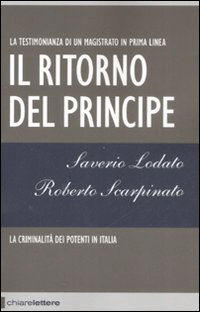 In Italia la questione criminale
In Italia la questione criminale
è inestricabilmente intrecciata con la storia
nazionale, segnata da una criminalità di potenti
plurisecolare, che oggi si perpetua
con le connessioni mafiose, e si traduce
in un mancato appuntamento
con l’illuminismo laico e liberale europeo
Palermo, 4 febbraio 2009. Roberto Scarpinato è uno dei magistrati storici della Procura di Palermo. Vi lavora da Procuratore, sostituto o aggiunto, dai tempi di Falcone e Borsellino. E’ stato testimone diretto degli eventi più tragici e importanti che hanno sconvolto la sua città e cambiato l’assetto politico, sociale ed economico del nostro Paese.
Impegnato in inchieste e processi di primo piano, il più celebre è quello al senatore a vita Giulio Andreotti, oggi Scarpinato coordina il pool che si occupa di misure di prevenzione e sequestri di beni. Il destino ha quindi voluto che la sua carriera esplosarre tutti gli aspetti della fenomenologia criminale che incarnano e ruotano attorno alla mafia siciliana: la forza militare, l’interconnessione con i poteri, politico e non, e il legame a doppio filo con l’imprenditoria che hanno consentito alla cosiddetta borghesia mafiosa di rafforzarsi nel tempo e di ascendere al potere nazionale.
Ecco quindi che ci ritroviamo al feudalesimo con il Principe che impone ed esige i suoi privilegi con qualunque mezzo a disposizione, sicuro di poter godere dell’impunibilità che la sua carica gli garantisce per diritto. Ecco quindi spiegato da un punto di vista storico e sociologico lo stato di sfacelo in cui versa l’Italia nostrana, mai diventata moderna, paralizzata da una classe dirigente che non si è mai evoluta, un Paese in cui non riesce a maturare una vera e piena democrazia.
Nel “Il ritorno del Principe” il procuratore Scarpinato risponde alle puntuali domande del giornalista Saverio Lodato e ripercorre così “le gesta” della criminalità dei potenti fino ai giorni nostri fornendo così fondamentali e inestimabili chiavi di lettura.
Uno strumento di eccezionale valore per tutti coloro che vogliono capire dove ci troviamo, e cosa sta accadendo attorno a noi e magari per intuire e cominciare ad imboccare una possibile via d’uscita. Abbiamo posto all’autore alcune domande.
Dottor Scarpinato, “Il ritorno del Principe” è una straordinaria quanto allarmante lettura del nostro tempo. Secondo quanto da lei sostenuto il nostro Paese non solo non pare in grado di compiere il salto evolutivo necessario per divenire una democrazia compiuta, ma sembra essere destinato a ripiegarsi su se stesso a vivere sempre le medesime dinamiche che lo imprigionano in una sorta di irrediminile girone dantesco. La sua analisi parte proprio dalla figura del Principe. Chi è questo Principe e cosa significa il suo ritorno?
Se si pone a confronto la storia italiana con quella di altri Paesi europei di democrazia avanzata si registra una significativa anomalia.
In questi Paesi la questione criminale è un capitolo marginale delle vicende nazionali che interessa solo gli specialisti di settore - criminologi, magistrati, poliziotti - perché, tranne poche eccezioni, riguarda solo le gesta della criminalità comune e della parte meno acculturata ed integrata della società civile.
In Italia invece la questione criminale è inestricabilmente intrecciata con la storia nazionale, quella con la S maiuscola, perché protagonisti delle vicende criminali sono stati e sono ampi settori delle classi dirigenti, il Principe appunto.
La nostra storia è segnata infatti da una criminalità dei potenti plurisecolare che si è manifestata essenzialmente su tre versanti: lo stragismo e l’omicidio per fini politici, la corruzione sistemica e la mafia.
Lo stragismo e l’omicidio politico sono rimasti una costante sin dal millecinquecento, quando già facevano parte della “normalità” italiana, come dimostra l’ammirazione tributata da Niccolò Machiavelli ad un notorio assassino e stragista quale era Cesare Borgia, duca di Valentino.
Nessuna storia nazionale europea è segnata da una catena così lunga ed ininterrotta di stragi come quella italiana.
Tralasciando le stragi del periodo monarchico e del Fascismo, basti pensare alla sequenza di stragi dal secondo dopoguerra italiano sino ai nostri giorni. Dalla strage di Portella delle Ginestre del 1 maggio 1947, a quella di piazza Fontana a Milano, a quella di piazza della Loggia a Brescia, all’Italicus e via elencando sino alle stragi politico-mafiose del 1992 e del 1993.
Attraverso quali strumenti la criminalità dei potenti ha stabilito ed esteso il suo dominio fino ad oggi? E con quali conseguenze per lo Stato, nelle sue componenti politiche, economiche ed istituzionali?
Il sigillo del potere, la regia di mandanti occulti eccellenti dietro molte di quelle stragi e di tanti omicidi politici si manifesta in vari modi.
Ad esempio mediante il depistaggio delle indagini della magistratura da parte di soggetti appartenenti ad apparati statali, come è stato accertato per la strage di Portella delle Ginestre e per quella di Bologna.
O ancora mediante l’assassinio degli esecutori materiali delle stragi, depositari di segreti scottanti che minacciavano di rivelare i nomi dei mandanti eccellenti. Tutti gli esecutori materiali della strage di Portella delle Ginestre furono assassinati. L’ultimo, Gaspare Pisciotta, fu ucciso all’interno del carcere dell’Ucciardone con un caffè corretto alla stricnina.
All’interno del carcere fu assassinato anche Buozzi, condannato in primo grado all’ergastolo quale uno degli esecutori materiali della strage di piazza della Loggia a Brescia.
Un’altra forma in cui si è manifestata la criminalità delle classi dirigenti è stata la mafia.
La mafia non è una creatura di personaggi come Provenzano e Riina, ma una creatura delle classi dirigenti nazionali.
Nel romanzo “I promessi sposi”, Manzoni descrive l’ordinarietà del metodo mafioso come metodo di gestione del potere nell’Italia del 1600.
L’essenza del metodo mafioso consiste nella prepotenza organizzata: cioè nell’abuso di potere personale di minoranze che avvalendosi dell’intimidazione derivante dal potere di cui sono dotate - potere sociale, economico, militare - creano uno stato di assoggettamento dei singoli piegandoli alla loro volontà.
Se andiamo a leggere la descrizione della fattispecie legale di associazione mafiosa possiamo constatare che non vi è alcun riferimento all’uso delle armi e alla violenza fisica, perché vi sono mille modi di esercitare prepotenza organizzata piegando gli altri: non vi è alcun bisogno di puntare la pistola alla tempia; ti posso ridurre sul lastrico, ti posso impedire di lavorare, di posso togliere dignità sociale e renderti la vita impossibile.
Nel romanzo “I promessi sposi”, don Abbondio si piega ai voleri di Don Rodrigo non solo perché ha timore dei suoi bravi - quelli che oggi chiameremmo i mafiosi dell’ala militare, gli specialisti della violenza - ma anche perché si trova in una condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dalla consapevolezza che Don Rodrigo fa parte di un mondo di potenti al di sopra delle leggi.
Nella stessa condizione si trova l’avvocato Azzeccagarbugli a cui Renzo Tramaglino si era rivolto nella speranza di trovare un rimedio legale contro la prepotenza, il quale rifiuta l’incarico quando apprende che avrebbe dovuto agire secondo legge contro un potente come Don Rodrigo al di sopra della legge.
In un’Italia, quella del Seicento, dove non esistono anticorpi sociali e legali contro un sistema di potere mafioso, Manzoni è costretto a far intervenire la Provvidenza perché la storia abbia un lieto fine: l’Innominato libera Lucia perché, colto da una improvvisa crisi esistenziale, si converte. Don Rodrigo viene fermato dalla morte che lo ghermisce con il contagio della peste.
In conclusione, la storia esemplificata come la sommatoria di potere militare (i bravi) e di potere sociale (il vincolo associativo derivante dalla solidarietà interna al mondo dei potenti) si traduca in un abuso di potere personale che sostanzia il metodo mafioso.
Questo metodo di esercitare il potere era riconosciuto come legittimo dall’ordinamento giuridico feudale fondato sulla natura personale del potere di papi, imperatori e via discendendo, all’interno di una società castale.
Ed è un metodo con il quale milioni di italiani hanno dovuto convivere per secoli da vittime o da carnefici. Perché dopo i Don Rodrigo del 1600 sono venuti i suoi eredi: baroni siciliani, l’aristocrazia papalina, quella borbonica e poi la borghesia mafiosa.
In Italia il feudalesimo è durato sino alle soglie del ventesimo secolo: in Sicilia, per esempio, fu abolito ufficialmente solo nel 1812, idem per il resto del meridione e per gli enormi possedimento dello Stato Pontificio in tutta Italia. In Piemonte la servitù della gleba si è protratta sino al 1789.
Quel medoto non è scomparso con la fine del tardo feudalesimo italiano e la nascita tardiva del primo nucleo di stato liberale di diritto dopo l’unificazione.
Tuttavia, mentre prima il metodo mafioso poteva essere esercitato alla luce del sole perché riconosciuto legale dall’ordinamento feudale fondato sul potere personale e sul dovere di obbedienza, poi con l’avvento dello stato liberale, si è trasformato in metodo esercitato illegalmente e quasi segretamente.
Il primo ad accorgersene fu Leopoldo Franchetti, un notabile toscano, uomo della destra liberale che nel 1866 pubblicò un’inchiesta sulla mafia che a distanza di più di un secolo conserva una sconcertante attualità.
Franchetti scopre che la mafia non era - come lui e tanti in buona fede credevano - un problema di ordinaria criminalità gestibile con gli usuali strumenti di Polizia e di ordine pubblico.
Capisce che la mafia è un mix micidiale di cervello borghese e lupara proletaria.
Si rende infatti conto che i principali capi della mafia sono “facinorosi della classe media”, cioè esponenti della classe dirigente che usano la violenza mafiosa come metodo di gestione del potere e come strumento di lotta politica per reprimere le rivendicazioni dei ceti popolari per un miglioramento delle loro condizioni economiche.
La somministrazione concreta della violenza viene delegata ai mafiosi con la coppola storta - eredi dei bravi di Don Rodrigo e progenitori dei vari Riina e Provenzano - i quali in cambio dei loro servigi ottengono libertà di predazione sul territorio tramite le estorsioni e protezioni.
Da qui, secondo Franchetti, l’irredimibilità del problema mafia. Ed infatti, poiché la mafia è un’espressione criminale delle classi dirigenti locali solo il governo nazionale potrebbe debellare la mafia. Ma poichè i governi nazionali - osserva Franchetti - per reggersi hanno bisogno dell’apporto determinante delle classi dirigenti meridionali, non possono intervenire.
In altri termini i Borgia e i Don Rodrigo continuano a cavalcare la storia anche dopo la nascita del nuovo stato liberale, e la mafia resta un affare di famiglia interno alla classe dirigente nazionale irresolubile perché ha una dimensione macropolitica che attiene agli equilibri politici nazionali.
La diagnosi di Franchetti conserva una straordinaria attualità che attraversa i secoli.
Così come nell’Ottocento, tranne la parentesi corleonese durata dagli inizi degli anni Ottanta agli inizi degli anni Novanta, i più importanti capi mafia sono sempre stati borghesi: il capo della mafia di Corleone prima di Riina e Provenzano era il dottor Michele Navarra, medico chirurgo. Il capo della mafia di Palermo negli anni Ottanta era Michele Greco, un distinto proprietario terriero, ospite dei migliori salotti palermitani.
Alcuni dei più importanti capi della mafia oggi sono medici, avvocati, imprenditori, professionisti.
Quando si fa l’elenco dei poteri forti in Italia, si dimentica sempre di indicare la borghesia mafiosa siciliana e la massomafia calabrese.
Nel suo libro lei introduce il concetto di “codice culturale della corruzione”, cosa intende dire? E per quali processi individuali e collettivi si è giunti ad una sostanziale accettazione e condivisione del “sistema corruzionale”?
Dall’unità d’Italia nessuno ha potuto governare senza tenere conto della forza politica di questo pezzo di classe dirigente e del blocco sociale che esprime.
Non è un caso che quando nel 1996 la sinistra ha iniziato ad assumere responsabilità di governo, ha completamente cancellato dalla sua agenda il tema dei rapporti mafia-politica.
Oltre allo stragismo e al metodo mafioso, un altro modo in cui si è declinata nei secoli la criminalità dei potenti in Italia è stata la corruzione.
Se si esamina la storia della corruzione in Italia, si può constatare come sin dai tempi della Monarchia si registra una differenza sostanziale tra il nostro Paese ed altri Paesi europei.
La differenza è che altrove la corruzione è una sommatoria di casi singoli, di cadute individuali che vengono riprovate pubblicamente.
In Italia, invece, la corruzione si manifesta subito come sistemica, come codice culturale della classe dirigente che si autogarantisce l’impunità.
Esemplare a questo proposito è il caso dello scandalo della Banca Romana esploso nel 1893.
La Banca Romana era una delle cinque banche nazionali autorizzate a stampare carta moneta per conto dello Stato.
Si scoprì che i dirigenti della Banca con la copertura dei vertici della politica nazionale, avevano stampato banconote false duplicando i numeri di serie per una cifra spropositata.
Inoltre, la Banca aveva erogato crediti senza garanzie e quindi inesigibile al fior fiore della nomenclatura del potere del tempo: parlamentari della destra e della sinistra, ministri, ex ministri, palazzinari legati alla famiglia reale, giornalisti di grido: in totale circa 150 pezzi da novanta.
Il crack ad un certo punto divenne inevitabile ed iniziò una indagine penale.
Il processo, apertosi a Roma nel 1894, si concluse dopo sessantuno udienze con l’assoluzione di tutti gli imputati: i responsabili della Banca, un deputato e due funzionari preposti alla vigilanza dell’istituto.
I fatti accertati rimasero dunque senza colpevoli.
Nelle indagini era rimasto coinvolto anche il Presidente del Consiglio Giolitti, su cui mandato funzionari di Polizia durante il sequestro degli atti, avevano fatto sparire casse di documenti scottanti che coinvolgevano politici e membri della famiglia reale.
Allo scandalo della Banca Romana, seguirono decine di altri scandali come quello della Banca Italiana di Sconto che coinvolse, oltre che numerosi colletti bianchi, anche quattro senatori del regno per i quali il Senato si costituì in Alta Corte di Giustizia. Quello del Banco di Sicilia, quello delle frodi per le forniture militari: scandali tutti conclusisi con assoluzioni generali.
La tangentopoli itliana non si è mai fermata ed ha attraversato il Fascismo, la prima e la seconda Repubblica giungendo sino ai nostri giorni.
Le storie di oggi sono la replica e la riedizione di quelle di ieri e dell’altro ieri. Anche nei loro esiti: l’eterna impunità garantita in un modo o in un altro a tutti i protagonisti delle vicende corruttive e la trasversalità della corruzione.
La straordinaria continuità storica della corruzione sistemica nella storia italiana dimostra quanto, a mio parere, sia depistante continuare a parlare di questione morale.
Una patologia del potere che dura ininterrottamente da più di un secolo e mezzo godendo - in un modo o in un altro - di eterna impunità, va interpretata per quello che realmente è.
Un codice culturale che plasma la forma stessa di esercizio del potere.
In altri termini la corruzione in Italia non è una deviazione del potere, ma una forma “naturale” di esercizio del potere che gode di accettazione culturale da parte della classe dirigente e che conta sulla rassegnazione culturale da parte delle classi sottostanti.
La corruzione fa parte della costituzione materiale del Paese; è una componente organica della politica italiana e dunque è una questione macropolitica con la quale occorre fare i conti a livello macroeconomico.
Secondo la sua analisi quindi nel nostro Paese si è andato strutturandosi ed evolvendosi un sistema di potere con connotati decisamente criminali, com’è la situazione attuale?
Rispetto al passato c’è una novità peggiorativa.
Prima l’abuso di potere e la corruzione dovevano essere praticati sottobanco perché illegali, ora invece l’abuso e la corruzione possono essere praticati alla luce del sole perché di giorno in giorno vengono legalizzati.
Ricapitolando, poiché la questione criminale in Italia coinvolge ampi settori delle classi dirigenti, non solo è inestricabilmente intrecciata alla storia nazionale, ma è inscindibile della questione democratica e da quella dello Stato.
A secondo nel mondo in cui si evolve la criminalità del potere, possono infatti mutare gli equilibri politici, può cambiare lo stesso modo di essere in concreto della democrazia.
Un francese, un inglese, un tedesco possono tranquillamente ignorare le vicende criminali dei loro Paesi. Ma un italiano che ignori la storia ed i percorsi della criminalità del potere è privo di una chiave di lettura essenziale per decifrare la realtà che lo circonda.
Non è in grado di capire perché in certi tornanti essenziali la storia ha preso una certa direzione invece che un’altra, perché muta il panorama istituzionale, quali siano i reali motivi sottesi all’emanazione di certe leggi al di là dei motivi ufficiali.
Non è in grado di capire perché il Paese rischi ciclicamente il tracollo economico a causa della storica incapacità di ampi settori delle sue classi dirigenti di autolimitare le prassi predatorie delle risorse collettive.
Non è in grado di capire perché oggi la criminalità dei potenti stia contribuendo a condannare il nostro Paese al degrado civile e al declino economico.
In sintesi, in un Paese come il nostro la criminalità dei potenti è una componente essenziale delle dinamiche macropolitiche e macroeconomiche che incide non solo sui processi di composizione e di scomposizione del potere, ma anche sul destino economico dell’intera nazione.
Oggi rispetto al passato assistiamo a quella che sembra la rottura di tutti gli argini.
La corruzione, come dicevo prima, ormai viene sempre più legalizzata e praticata alla luce del sole mediante la depenalizzazione di vari reati, mediante la legalizzazione del conflitto di interessi, cioè dell’interesse privato in atti di ufficio, mediante la progressiva lobotizzazione degli strumenti di indagine (vedi riforma delle intercettazioni).
Il metodo mafioso, come notano preoccupati criminologi e magistrati, si diffonde a macchia d’olio all’interno del mondo dei colletti bianchi, travalicando i confini delle mafie tradizionali sul territorio.
Dal Nord al Sud in centinaia di processi emergono associazioni a delinquere, comitati di affari, network di potere costituiti da colletti bianchi che utilizzano metodologie mafiose per conquistare illegalmente spazi di potere e per condurre i loro affari.
Si affermano sempre di più nuove soggettività criminali complesse: i sistemi criminali. Una sorta di tavolo dove siedono figure diverse, non tutte necessariamente dotate di specifica professionalità criminale: il politico, l’alto dirigente pubblico, l’imprenditore, il finanziere, il faccendiere, il portavoce delle mafie.
Ciascuno di questi soggetti è referente di reti di relazioni esterne al network, ma messe a disposizione dello stesso. Il sistema è modulare nel senso che, a secondo della natura degli affari e delle necessità operative, integra nuovi soggetti o ne accantona altri. I diversi tavoli di lavoro pianificano la divisione dei compiti per conseguire il risultato del controllo di ampi settori delle Istituzioni, dei centri di spesa, e della spartizione delle opere e dei fondi pubblici.
A volte i vari sistemi criminali operanti nel territorio diventano intercomunicanti tramite uomini cerniera. Per intenderci potremmo definire i sistemi criminali come mutanti che nascono dall’evoluzione e dall’ibridazione di precedenti forme criminali: corruzione, piduismo e mafia. Le cronache offrono un campionario della fitta rete di sistemi criminali che dal Nord al Sud come un esercito di termiti succhiano segretamente la linfa vitale del Paese.
Nelle regioni meridionali hanno una maggiore visibilità solo perché la loro esistenza emerge in occasione delle indagini classiche sulle oganizzazioni mafiose operanti sul territorio.
Intercetti il mafioso e quello parla con l’imprenditore che a sua volta si rapporta con il politico che mette in campo il finanziere ecc.... un filo di Arianna che porta dentro i labirinti del potere e dei grandi affari.
Siamo alla post mafia. Se prima si utilizzava la categoria giuridica e concettuale del “concorso esterno” in associazione mafiosa per indicare i colletti bianchi esterni alle organizzazioni mafiose che colludevano in vario modo con le stesse a livello individuale, ora sarebbe più corretto parlare di concorso esterno delle organizzazioni mafiose negli affari sporchi di ampi settori delle classi dirigenti.
A cosa si deve questa rottura degli argini prima esistenti?
Credo che abbia contribuito il venir meno di un fattore che sino alla fine della prima Repubblica aveva agito da occulto calmiere, da contrappeso alla incapacità di autoregolazione delle classi dirigenti.
Mi riferisco al pericolo del sorpasso a sinistra che ha caratterizzato la storia del dopoguerra italiano.
La classe dirigente doveva autolimitarsi e venire a patti dovendo misurarsi con la realtà sociale e politica del più forte partito comunista europeo e soprattutto di una classe operaia che aspirava a divenire classe generale assumendo la responsabilità della direzione dello Stato mediante alleanze strategiche con il mondo riformista cattolico e la parte più evoluta della società civile.
Votare a sinistra era per quella parte della società civile un modo di esprimere la propria insoddisfazione e la propria insofferenza per un sistema che nelle sue degenerazioni diveniva intollerabile.
L’alternativa della sinistra veniva vissuta non come un’alternanza di oligarchie al potere che non cambiava l’ordine delle cose, né come un sovvertimento della democrazia, ma come la possibile costruzione di un altrove politico.
Ricordiamo il successo della questione morale sollevata da Luigi Berlinguer.
Di fronte al pericolo del sorpasso a sinistra, la parte più violenta della classe dirigente ha reagito con lo stragismo e gli omicidi politici che hanno segnato la storia della seconda Repubblica dalla strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947 alle stragi del 1993.
Un’altra parte della classe dirigente ha dovuto invece mediare, sfiatando le ragioni dello scontento popolare con la progressiva costruzione dello stato sociale dei diritti.
Dopo la caduta del muro di Berlino e la sopravvenuta irrilevanza storica e sociale della classe operaia, l’antagonismo sociale si è completamente disarticolato ed ha perduto la possibilità di una canalizzazione politica.
Il venir meno del controbilanciamento del pericolo del sorpasso a sinistra ha inaugurato la stagione delle mani libere che si traduce nella deregulation cioè nella sistematica abolizione delle regole e dei diritti sia nell’economia che nella politica.
Quello a cui stiamo assistendo è così uno straordinario ritorno al passato: un passaggio dalla modernità imperniata sul primato del potere impersonale della legge uguale per tutti alla premodernità di un potere - quale era quello tardofeudale - personale svincolato da controlli e al di sopra delle leggi all’interno di una società ristrutturata in modo piramidale e castale.
Il neofeudalesimo italiano, affollato da tanti vassalli in cerca del loro Principe, di sudditi contenti di esserlo, di intellettuali la cui massima aspirazione è quella di divenire il “consigliori” del Principe di turno e di essere iscritto al suo libro paga, è una riedizione della storia più antica e autentica del Paese.
La storia di un Paese che ha mancato il suo appuntamento con la modernità.
Siamo passati direttamente dalla premodernità del tardofeudalesimo quando lo stato di diritto non era ancora nato, alla postmodernità caratterizzata dalla crisi mondiale dello stato di diritto, senza avere avuto il tempo di vivere quella straordinaria stagione della modernità che nei secoli diciottesimo e diciannovesimo ha prodotto in Paesi come la Francia, l’Inghilterra, la Germania, le culture dell’illuminismo, del liberalismo, del laicismo alla base della fondazione dello stato di diritto.
Così la vecchia cultura della roba si è saldata, quasi senza soluzione di continuità, alla nuova cultura del profitto senza regole e senza limiti.
[Tratto da AntimafiaDuemila n. 1-2009]
FOTO: Roberto Scarpinato e Saverio Lodato
Il ritorno del Principe
Ed. Chiarelettere - pag. 347 - e 15,60
|