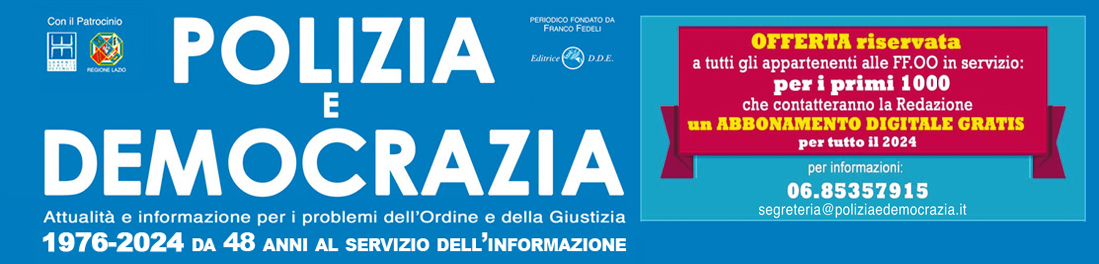Che senso ha la pena oggi? Che senso ha una pena che si riproduce apparentemente senza scopo, come esito finale di una macchina che si muove per inerzia e che inerzialmente assorbe e sputa corpi e vite che le sono capitate negli ingranaggi?
di Stefano Anastasìa
La Costituzione pone un limite e fissa uno scopo. Il limite, condiviso da ogni ordinamento giuridico degno di questo nome, tanto da essere universalmente riconosciuto nella Dichiarazione dei diritti umani nelle Nazioni unite, è quello del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (difficile capire come esso sia compatibile con la previsione normativa della pena di morte, ancora diffusa fuori dall’Europa, ma tant’è…). Lo scopo è quello della “rieducazione”, e dunque – fuori da antiquate concezioni moralistiche o autoritarie – quanto meno della prospettiva del reinserimento sociale del condannato in condizioni di autonomia e legalità. È questo, tutt’ora, l’approdo normativamente più avanzato delle concezioni utilitaristiche della pena, di una pena utile allo stesso tempo per la società e per il condannato, ispirate al principio della prevenzione speciale positiva. Peccato però che la finalità rieducativa della pena nel nostro ordinamento resti più una linea di resistenza che una prospettiva perseguita dal sistema penitenziario nei confronti della generalità dei detenuti. Si fa ricorso alla rieducazione più negli argomenti per evitare trattamenti contrari al senso di umanità (come nel caso della contestazione dell’ergastolo ostativo) che nelle pratiche quotidiane e nell’organizzazione del sistema penitenziario.
Il risultato è che gran parte dei condannati che passano per le nostre carceri non hanno alcuna “offerta rieducativa”: talvolta perché condannati a pene troppo brevi per avere una risposta dal sistema, talaltra perché manca il personale educativo in grado di programmare l’offerta di qualcosa o perché il territorio non offre alcuna collaborazione al mondo chiuso del carcere. Quella esigua minoranza di condannati che riescono a seguire in carcere un percorso come quello delineato da leggi e costituzione è composta da coloro a cui le stelle si sono allineate nel cielo, certo, anche per merito loro, di una loro intelligenza, resilienza e disponibilità, ma poi perché erano in quel carcere e non in quell’altro, perché hanno avuto quel direttore e non quell’altro, quell’educatore e non quell’altro, quel magistrato e non quell’altro, quell’avvocato e non quell’altro, perché avevano una casa, una famiglia, una comunità disposta ad ospitarli. Troppe variabili per escludere che la rieducazione non sia una cabala, con tutta l’aleatorietà della cabala.
La verità è che lo scopo della pena come rieducazione finalizzata al reinserimento sociale del reo in condizioni di autonomia e legalità è legato indissolubilmente all’ideale universalista e solidarista dell’articolo 3 della nostra Costituzione e, in generale, del costituzionalismo democratico: se e quando vengono meno quei presupposti, se i servizi educativi, per l’impiego, socio-sanitari vengono progressivamente meno per la generalità della popolazione, come si può pensare che sopravvivano solo per chi ha commesso dei reati? La rieducazione resta così una vetrina delle buone intenzioni cui accedono i fortunati cui si sono allineate le stelle nel cielo.
Non è un caso, appunto, che la rieducazione venga sempre più spesso evocata per confinare pratiche degradanti e non si riconosca come tale la giurisprudenza umanitaria che si è andata affermando negli ultimi decenni, in Italia e altrove, da quando – appunto – la labilità dell’ideale rieducativo ha lasciato spazio a una pena senza scopo, rispondente solo alla funzione di esclusione simbolica e di incapacitazione dei nemici del popolo o dei fantasmi dell’insicurezza sociale: i tossicodipendenti, i migranti, i senza fissa dimora, ora o tra poco i malati di mente, che i servizi di salute mentale non riescono più a gestire, ma anche i mafiosi, i corrotti, i potenti finalmente caduti.
Questo è il coté entro cui matura il sovraffollamento strutturale e la disperazione che porta al suicidio decine di detenuti e non pochi agenti di polizia penitenziaria, stremati dalla fatica o disorientati dalla perdita di senso della loro professione.
Molto si chiede e molto si spera, oggi, nella giustizia riparativa, come alternativa a una giustizia tradizionale scissa tra presupposti di legittimazione e realtà concreta, tra scopo teorico e funzione effettiva del suo esercizio. Certamente molto può dare l’idea riparativa a una pena non più o non solo degradante, ma è improbabile che essa possa affermarsi come ancella della giustizia tradizionale, con il rischio di trasformare la ricerca dell’incontro in una pena accessoria.
La verità è che un’altra idea di giustizia, come un’altra idea di pena, hanno a che fare con un’altra idea di società: il sistema penale e quello penitenziario non si salvano da soli, per invenzione illuminata della dottrina, dei giuristi o del legislatore, ma se nella società matura un’altra idea di convivenza, di garanzia dei diritti e, quindi, di composizione dei conflitti, perché, come scrive Luigi Ferrajoli nel suo ultimo libro (“Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale”, Laterza 2024) «il diritto penale è l’ultima e la più infelice delle tecniche di garanzia che i sistemi politici hanno il compito di assicurare ai diritti e alla sicurezza pubblica. Ben prima che con politiche penali, la criminalità si previene con politiche economiche e sociali e con adeguate riforme istituzionali. Ben più che con le pene, i diritti fondamentali, compresa l’immunità da ingiuste offese e da ingiuste punizioni, si garantiscono con potenti sistemi di garanzie sociali», quel che oggi ci manca e che anima gli abusi populisti del diritto e della giustizia penale.
Articolo tratto da garantedetenutilazio.it